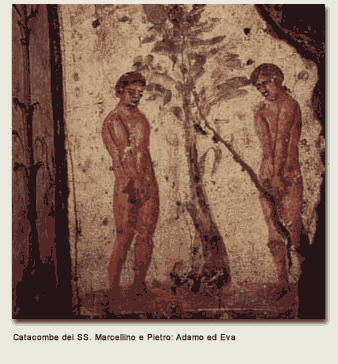
Dal Vangelo secondo Marco 10,1-12.
Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l'ammaestrava, come era solito fare. E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: «E' lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?». Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio».
IL COMMENTO
Vi sono domande che non cercano risposte. Domande che sembrano pistole puntate. Gesù ne ha fatto più volte esperienza. E il tema del vangelo di oggi è di quelli scottanti, duemila anni fa come oggi. I farisei conoscevano perfettamente la Torah. E, di essa, ogni cavillo legislativo. Essi si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova, per coglierlo in fallo, per poterlo denunciare come eretico. Loro conoscevano quello che stabiliva Mosè circa il ripudio. Interrogano Gesù per sapere cosa ne pensasse, della Legge e di Mosè. In definitiva, con una domanda trabocchetto, volevano sapere che cosa Gesù pensava di loro, paladini della purità e del compimento ella Legge. Tante nostre discussioni conservano lo stesso sapore. Sappiamo bene dove sia la verità, e domandiamo, parliamo, ci scaldiamo mossi solo dal desiderio di veder crollare i nostri interlocutori, di tracciare un segno ben marcato a dividere gli "altri" tra amici e nemici. Molte, troppe volte, parliamo per poter viaggiare sicuri nelle nostre decisioni e sapere chi è dei nostri e chi non lo è.
Ma Gesù conosceva il cuore dei farisei. E conosce il nostro. Lui è Dio. E risponde, inaspettamente, con una domanda. Una domanda piena d'amore. Avrebbe potuto stare lì a discutere, umiliare, deridere, vincere la sua battaglia ideologica, smascherare la perfidia e l'ipocrisia dei farisei. Lo potrebbe fare mille volte con noi. Invece il Suo amore colpisce al cuore, incarnato nelle sue parole che, come una lama a doppio taglio, penetrano sino alle giunture più recesse dello spirito. Le sue parole, un bagliore di luce nell'oscurità del cuore indurito. Dei farisei. Di ciascuno di noi. E' questa la parola chiave del Vangelo di oggi: sklerokardia, la malattia del nostro cuore. E' un termine rarissimo nel Nuovo Testamento, è usato solo qui (e nel parallelo di Mt. 19,8) e nel finale di Marco, quando Gesù risorto, apparendo ai discepoli, li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore. La malattia del cuore è dunque l'incredulità.
Si comprendono allora meglio le parole di Gesù sull'indissolubilità del matrimonio se le poniamo nel loro proprio contesto che è la fede. I farisei sono ciechi, non comprendono nulla di Gesù, esattamente come i discepoli. Non hanno fede. Il cammino sin qui percorso da Gesù, i fatti, i miracoli, le sue parole, ce lo hanno svelato. Pietro stesso, la mente preda di pensieri secondo il mondo, è apostrofato satana dal suo Maestro. E il menzognero sin da principio ispira anche i pensieri e le infide domande dei farisei. Gesù parlando di un "ordine" da parte di Mosè apre la porta della verità dinnanzi ai farisei. Mosè non ha dato alcun ordine riguardo al ripudio. In Dt. 24, 1-4, l'unico passo della Torah che ne tratta, il divorzio è scontato. In esso si tratta più specificatamente del caso di un uomo che ha ripudiato la moglie e vuole sposarla di nuovo, dopo che ella è stata sposa di un altro uomo. I farisei, che conoscono la Legge, rispondono infatti che non v'è nessun ordine in materia, ma solo un permesso. Si permette qualcosa non solo perchè sia valida, ma, a volte, si permette di fare qualcosa anche per riguardo alla debolezza. O per la durezza di cuore. Non si tratta quindi di liceità o meno. Il matrimonio è qualcosa di molto più grande, riguarda il principio, riguarda Dio. E, in Lui, gli uomini, gli sposi. E' il peccato d'orgoglio di Adamo ed Eva che ha rotto l'equilibrio d'amore pensato da Dio. E' stata la loro incredulità dinnanzi al potere di Dio a spezzare il progetto di Dio sulla Sua creatura. La durezza di cuore che percorre tutta la storia di Israele, come cristallizzata nelle parole dei farisei del vangelo di oggi. La nostra durezza, la nostra malattia.
Il matrimonio, tale come traspare dalle parole di Gesù, è essenzialmente una Buona Notizia, è l'amore di Dio donato all'uomo, è l'opera che Dio ha pensato creando l'uomo. Infatti la Scrittura, per parlare del rapporto tra Dio e l'uomo, usa immagini nuziali di rara bellezza. E di sconosciuta misericordia. Dio ha sempre avuto misericordia del Suo Popolo, anche quando ne è stato tradito più vergognosamente. E lo ha sempre perdonato, amato, e perdonato. Non v'era dunque solo un principio davanti agli occhi dei farisei. Vi era anche una storia di secoli, storia di misericordia dalla quale attingere per comprendere il mistero del matrimonio. Ma, come appare chiaro nel vangelo, la storia sino a quel giorno non era bastata. Come non basta per noi. Era necessario qualcosa di più, l'amore sino alla fine di Cristo. La croce, il letto d'amore dove Dio, nel Suo Figlio, ha sposato tutti noi, il legno dove ci ha fatti carne della sua carne, una sola cosa con Lui. La parola della croce è la luce che promana dalle parole di Gesù. In essa Lui ha compiuto quel che oggi ci annuncia. Il principio nel quale Dio ha creato l'uomo a sua immagine, maschio e femmina, perchè fossero una sola carne e che nessuno avrebbe mai dovuto separare, l'amore che Dio ha pensato per ogni uomo, trova il compimento nella croce del Figlio. La fede nella croce, nel suo amore infinito, è il fondamento d'ogni matrimonio. Non si tratta di carattere, affinità, etc. Si tratta di fede dinnanzi alla croce, la fede di chi ha sperimentato l'amore di Dio capace di sciogliere un cuore indurito. L'amore che vince l'incredulità, le sue piaghe gloriose nelle quali sono impressi i nomi di tutti noi.
"Sempre sussiste, tuttavia, la possibilità di ribellarsi contro quel disegno d'amore: si ripresenta allora quella "durezza del cuore" (cfr Mt 19, 8) per la quale Mosè permise il ripudio, ma che Cristo ha definitivamente vinto. A tali situazioni bisogna rispondere con l'umile coraggio della fede, di una fede che sostiene e corrobora la stessa ragione, per metterla in grado di dialogare con tutti alla ricerca del vero bene della persona umana e della società. Considerare l'indissolubilità non come una norma giuridica naturale, ma come un semplice ideale, svuota il senso dell'inequivocabile dichiarazione di Gesù Cristo, che ha rifiutato assolutamente il divorzio perché "da principio non fu così" (Mt 19,8). Il principio del disegno di Dio ci è consegnato oggi nella Croce del Signore. La sua croce nella nostra, il luogo dove ci dà ogni giorno appuntamento per essere con Lui una sola carne. E, in lui, una sola carne marito e moglie, spesso "croci" gli uni per gli altri, e, quindi, nel Signore, più saldamente uniti. Indissolubilmente. E' nella croce che Dio li ha uniti, per sempre. Il verbo greco synezeuxen che indica "congiunto" infatti, è formato dalla preposizione-prefisso syn ("con") e dalla radice zeug-, che descrive anche due animali uniti dal "giogo" (zeugos). Il giogo che unisce gli sposi è dunque il giogo di Cristo, mite e umile di cuore. Esso è leggero e dolce perchè è l'unico adeguato a ciascuno dei due, l'unico che li fa, giorno dopo giorno, una sola carne. Non può esservi giogo diseguale, pena inciampare, cadere, rompere l'unità. Il giogo di Cristo, le sue braccia distese ad unire gli sposi, il suo amore infinito che ogni giorno perdona, e fa perdonare; ama e dona di amare. Che Dio conceda a tutti noi la fede capace di aprire gli occhi sulla croce gloriosa del Signore risorto, e credere all'amore che vince ogni male, la fonte di vita per ogni matrimonio, il giogo soave che conduce gli sposi, indissolubilmente uniti, sino al Cielo.
APPROFONDIMENTI
Giacomo di Saroug (circa 449-521), monaco e vescovo siriano
Hexameron ; Omelia per il sesto giorno
« Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza » dice Dio (Gen 1,26). Un semplice comandamento aveva fatto sorgere gli altri esseri della creazione : « Sia la luce ! » o « Sia il firmamento ! » Questa volta invece, Dio non dice « Siano gli uomini », ma dice : « Facciamo l’uomo ». Infatti riteneva conveniente che fosse plasmata dalle proprie mani questa sua immagine, superiore ad ogni altra creatura. Questa opera gli era particolarmente vicina ; la amava di un grande amore… Adamo è l’immagine di Dio perché porta l’impronta del Figlio Unigenito…
In un certo modo, Adamo è stato creato allo stesso tempo uno e duplice ; Eva si trovava nascosta in lui. Prima ancora che esistassero, l’umanità era destinata al matrimonio, che li avrebbe ricondotti, uomo e donna, a un solo corpo, come era in principio. Nessun litigio, nessuna discordia doveva sorgere fra loro. Avrebbero avuto un solo pensiero, una sola volontà… Il Signore ha plasmato Adamo con polvere e acqua ; dalla carne, dalle ossa, e dal sangue di Adamo ha tratto Eva. Il torpore del primo uomo anticipava i misteri della crocifissione. Il costato aperto, era il colpo di lancia portato al Figlio Unigenito ; il sonno, la morte di croce ; il sangue e l’acqua, la fecondità del battesimo (Gv 19,34)… L’acqua e il sangue però che sgorgarono dal fianco del Salvatore sono all’origine del mondo secondo lo Spirito.
Adamo non ha sofferto per il prelievo fatto nella sua carne ; ciò che gli era stato rubato, gli è stato reso, trasfigurato dalla bellezza. Il soffio dei venti, il mormorio degli alberi, il canto degli uccelli chiamavano i fidanzati : « Alzatevi, avete dormito abbastanza ! Vi aspetta la festa nuziale » … Accanto a lui, Adamo visse Eva, che era sua carne e sue ossa, sua figlia, sua sorella, sua sposa. Si alzarono, avvolti di un vestito di luce, nel giorno che sorrideva loro. Erano nel Paradiso.
Bruna Costacurta
Genesi 1-4: creazione, peccato e redenzione.
Una introduzione
Durante questi giorni noi leggeremo i primi capitoli della Bibbia. Siamo davanti a dei testi che sono diversi da qualunque altro testo scritto, siamo davanti alle Scritture Sante. La Bibbia è Parola di Dio in parole degli uomini. La Parola di Dio, che è una parola eterna, assoluta, non relativizzabile, unica, immutabile, si fa parole umane. Che non sono eterne affatto, che non sono uniche perché ne esistono molteplici, che sono condizionate. Dunque nella Scrittura c’è come una sorta di incarnazione della Parola di Dio nelle parole umane. Utilizzo il termine incarnazione ovviamente in senso analogico, non parlo di incarnazione in senso tecnico, però avviene qui qualcosa di analogo a quello che è avvenuto con l’incarnazione.
Peraltro, questo l’ha detto in modo molto esplicito la Dei Verbum, il documento conciliare, che dice:
Le parole di Dio, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile agli uomini (DV13).
Quindi vedete, il rapporto è evidente. C’è questo farsi carne, se volete, farsi parole umane della Parola analogamente a come il Verbo si è fatto carne facendosi simile agli uomini. Se è così voi capite che queste due dimensioni, Parola di Dio e parole di uomini, non si possono più staccare, sono ormai assolutamente inscindibili in questo testo. Possiamo continuare l’analogia: nel Signore Gesù è Dio e l’uomo, e non si può separare una realtà dall’altra, nel senso che c’è una vera fusione per cui, come si dice nella teologia, la persona è una. Le nature sono due, ma la persona è una.
C’è qualcosa di analogo nel nostro testo. Noi abbiamo un testo che è uno, dove però le parole sono contemporaneamente di Dio e degli uomini. Il compito di chi vuole capire questi testi, di chi vuole leggerli, di chi vuole pregarli, è tenere insieme queste due realtà, obbedendo alle due dimensioni, dunque in una prospettiva di fede che è assolutamente irrinunciabile. Non si può leggere il testo biblico, in quanto biblico, senza questa prospettiva di fede. Sempre la Dei Verbum esplicitò a suo tempo, quarant’anni fa, qualcosa di assolutamente importante, che ha rappresentato una svolta anche nella ricerca e nello studio dei testi biblici: il prendere sul serio la nozione dei generi letterari.
Se ne è molto discusso prima del Concilio e poi la DV dice esplicitamente che bisogna tenere conto, leggendo la Bibbia, anche dei generi letterari. Questo adesso a noi sembra ovvio, a quei tempi non lo era. E’ chiaro che se io leggo un salmo, che è una preghiera in forma poetica, dunque una poesia ed una preghiera, istintivamente avrò un atteggiamento, un modo di leggerlo e di capirlo, diverso da quello che avrò nel leggere una pagina del Libro dei Re dove si racconta la storia di un re di Israele. Perché nel Libro dei Re si vuole raccontare una storia, mentre nel salmo non si vuole raccontare una storia, si vuole pregare in forma poetica. Un conto è leggere una lettera di S.Paolo, un conto leggere i primi capitoli del Libro della Genesi, inevitabilmente.
Questo, che è così ovvio, andrebbe, in modo altrettanto ovvio, applicato alla Scrittura nella sua globalità. Nel senso che dentro la Scrittura ci sono tanti generi letterari, ma la Scrittura Santa è, se non un particolare genere letterario, perché quella di genere letterario è una nozione tecnica, un particolare genere di letteratura. Che è appunto questa cosa unica e particolare in cui abbiamo insieme la Parola di Dio e le parole degli uomini. Questo fa di questo libro un libro che è un genere a sé.
Allora, come noi rispettiamo i generi letterari, per cui un conto è leggere un Salmo, un conto è leggere il Libro dei Re, allo stesso modo, un conto è leggere la Bibbia, un conto leggere Omero. Un conto è leggere il testo biblico, un conto leggere un testo di letteratura, per quanto bello esso sia. Questo di solito è qualche cosa di ovvio che addirittura noi facciamo, quando siamo davanti ad un testo, in modo istintivo. Faccio sempre un esempio per farmi capire. Se io qui comincio a dire: “C’era una volta una bambina che aveva un bel vestitino con un cappuccio rosso, e la mamma le disse – vai a trovare la nonna nel bosco!”. Voi mi sentite raccontare o leggete una cosa del genere e capite immediatamente che è una favola (c’era una volta…), in particolare la favola di Cappuccetto rosso e quindi immediatamente vi mettete nella condizione di spirito e nell’atteggiamento conoscitivo di chi è davanti ad una favola, da cui ci si aspetta un insegnamento, una morale, non altre cose.
Diverso è se voi invece aprite un testo di anatomia, di fisiologia. E’ chiaro che si tratta di un’altra cosa, non ti devono dire una morale, ti devono dire come è fatto lo stomaco di un cavallo. Istintivamente si assume un altro atteggiamento. Se io racconto la storia di Cappuccetto Rosso e qualcuno di voi alza la mano, dopo aver riflettuto, dopo aver molto pensato, e mi dice: “Devo fare una domanda; quando arriva il cacciatore, apre la pancia del lupo e Cappuccetto Rosso esce viva. Ma allora i lupi nello stomaco non hanno i succhi gastrici come gli altri animali, quindi le vittime non vengono decomposte? Hanno un sistema gastro-intestinale diverso?” Uno sente una domanda del genere e dice: forse pensare fa male, ci si ammala a pensare troppo! Vai al mare, fai un bagno e dimentichiamo tutto. Perché è chiaro che non c’entra niente.
Se però io, invece, vi faccio una lezione di anatomia e vi spiego come sono fatti i canidi e quindi vi racconto come è fatto l’apparato gastrico di un cane, è chiaro che voi capite subito che io non ho nessuna morale da insegnare e a nessuno di voi viene in mente di alzare la mano e chiedere: “Allora forse nei tempi antichi i lupi avevano uno stomaco diverso, perché Cappuccetto Rosso esce viva! Forse durante la glaciazione si sono gelati anche i succhi gastrici dei lupi?”. Capite che non funziona?
E’ come quando uno racconta una barzelletta. Se gli altri non capiscono che sta raccontando una barzelletta e lo prendono sul serio, quello si spara! Insomma, bisogna rispettare i generi letterari. Questo vuol dire che quando noi siamo davanti alla Bibbia dobbiamo rispettare questo suo genere di letteratura assolutamente particolare e non possiamo né assumere questo testo solo come libro di letteratura e studiarlo come studieremmo Omero, né possiamo leggerlo come se fosse solo Parola di Dio per cui tutto quello che c’è scritto è assolutamente vero, è successo tutto proprio come è scritto. Dio disse: “Sia la luce”, ed era di domenica quando è successo. No! Né l’una né l’altra, ma tutte e due insieme. Questo è il punto.
Vuol dire che bisogna avere la pazienza di studiare questo testo come un’opera di letteratura. Dunque avere la pazienza di imparare la lingua o almeno di capire come funziona, stare attenti alle particolarità del testo - ci sono problemi di lessico, di sintassi, problemi testuali, particolarità stilistiche, tecniche di composizione particolari, che bisogna studiare e delle quali tenere conto. Bisogna sapere che questi testi, siccome sono testi di letteratura, nascono in determinati contesti storici e culturali e dunque sono condizionati da quei momenti storici e da quei contesti culturali. E dobbiamo sapere che sono contesti storici e culturali diversi dai nostri, e quindi non è vero che i nostri concetti corrispondono sempre a quelli.
Quando la Bibbia parla di giustizia non parla della giustizia come la intendiamo noi. Bisogna avere la pazienza e il coraggio di capire come ne parla la Scrittura e quindi di cambiare il nostro modo di pensare. Sono inoltre testi che hanno subito un travaglio di formazione molto complicato e molto lungo, non sono stati scritti di getto. Hanno avuto prima una tradizione orale, poi sono stati messi per iscritto in modi diversi, poi sono stati raccolti, poi li hanno risistemati, hanno fatto delle aggiunte e bisogna tenere conto di tutto questo. Solo che questo non basta e fare solo questo vorrebbe dire trattare la Bibbia alla stregua di uno che leggendo Cappuccetto Rosso si pone il problema dei succhi gastrici. No! Perché questa mentre è parola di uomo è anche Parola di Dio.
E se è Parola di Dio vuol dire che questo è un libro che è nato dalla fede, che è stato scritto nella fede e che è stato donato e tramandato per la fede del popolo di Dio. Quindi non si può leggere la Bibbia in quanto Bibbia se non in una prospettiva di fede. Allora bisogna tenere conto della lingua, dei vari strati, delle formazioni compositive, ma per arrivare al messaggio religioso, alla comprensione spirituale, per lasciarsi istruire nella fede e dunque farsi domande che non siano sui succhi gastrici, ma che tocchino direttamente la dimensione della fede e quindi la nostra personale vita di fede. Solo così noi leggiamo la Bibbia come Bibbia, altrimenti la leggiamo come un’altra cosa. Romano Guardini ha espresso così il principio epistemologico della conoscenza: nessun oggetto di ricerca può essere ben compreso se non da un modo di conoscere adeguato al suo oggetto.
Quindi nessun oggetto può essere capito se non si usa un percorso di comprensione o un modo di conoscere che non sia adeguato all’oggetto che si vuole capire. Se si usa un modo inadeguato all’oggetto non si capisce. Se questo oggetto non è solo parole di uomini e non è solo Parola di Dio, ma è Parola di Dio in parole di uomini, noi dobbiamo conoscerlo in un modo che sia adeguato a ciò che questo nostro oggetto di conoscenza è. Dunque indagare la dimensione storico-letteraria, studiare le particolarità lessicali, le ambientazioni culturali, ma sempre e inevitabilmente all’interno di un orizzonte di fede, un orizzonte credente e necessariamente in un atteggiamento orante. Da qui la necessità del silenzio, di un tempo di riflessione e di preghiera. Perché l’esegesi biblica, per essere davvero tale, deve essere accompagnata nella fede dalla preghiera e dall’obbedienza a questa parola che si studia. Dal desiderio orante di capire, ma di capire perché si è consapevoli che lì c’è in gioco il senso della nostra vita. E questo è vero per chi prende in mano la Bibbia per pregarla, ma è vero anche per chi prende in mano la Bibbia per studiarla. E se la studia senza pregarla, sta studiando un’altra cosa.
Parecchi anni fa venne presentato un documento della Pontificia Commissione Biblica, proprio sul modo di interpretare la Bibbia. E quando venne presentato questo documento il Papa fece un discorso molto bello. Disse tra l'altro:
E’ necessario che lo stesso esegeta percepisca nei testi la parola divina e questo non gli è possibile se non nel caso in cui il suo lavoro intellettuale viene sostenuto da uno slancio di vita spirituale. In mancanza di questo sostegno la ricerca esegetica resta incompleta. Essa perde di vista la sua finalità principale e si confina in compiti secondari.
Giovanni Paolo II qui non parla del credente che prende in mano la Bibbia in un giorno di ritiro, ma dell’esegeta. E’ una frase fortissima, ma è indubbiamente vera. Se serve un atto tecnico dell’analisi del testo, e serve perché se no non si capisce cosa il testo sta dicendo, questo atto tecnico però bisogna che in qualche modo cambi e assuma uno statuto diverso da quello che solitamente determina lo studio di altre realtà testuali. L’investigazione linguistica, storica, letteraria, tutto il lavorio dell’investigazione scientifica, che bisogna fare, e di cui io qui cercherò di dare i risultati, che è necessaria perché altrimenti non si capisce cosa c’è scritto nel testo, deve necessariamente aprirsi a delle valenze che la trascendono. Deve essere sostenuta da un atteggiamento di fede e di fede obbediente, deve diventare ricerca appassionata di Dio.
Questo è quello che io spero possa succedere in questi giorni ed è l’ambito nel quale io mi muovo per leggere questi testi.
La Bibbia deve essere letta in una prospettiva esplicitamente di fede. Perché si può anche aprire la Bibbia dicendo: “Io la studio. Poi dopo farò anche le mie cose spirituali, ma ora voglio studiare la Bibbia dal punto di vista scientifico, e la fede non c’entra niente, perché la fede, per sua natura, non è scientifica”. Un discorso di questo tipo è assolutamente non scientifico. Perché cosa è scientifico? Studiare un testo rispettando ciò che è. E’ scientifico studiare Cappuccetto Rosso in modo diverso da come studio scientificamente un trattato di fisiologia dell’apparato digerente. Leggere o studiare la Bibbia mettendo da parte la fede, almeno momentaneamente, senza implicare esplicitamente la fede, questo non è scientifico. Perché se manca la fede tu non stai rispettando l’oggetto che studi e quindi non sei scientifico. Sembra un paradosso perché uno pensa che non sia scientifico nominare Dio, ma è proprio il contrario.
Genesi 1
Genesi è un testo molto ricco dal punto di vista spirituale, teologico, antropologico, quindi non ci sarà il tempo per commentarlo versetto per versetto, ma vi darò alcune indicazioni che poi possono servire per la riflessione personale. Va subito chiarito quello che tutti sappiamo: ci troviamo, all’inizio della Bibbia, con due racconti di Creazione. Gen 1 con il racconto dei sette giorni, e Gen 2 con il giardino e l’uomo fatto dalla terra. Sono due racconti molto diversi. Il primo ha un andamento innico, molto solenne. Il secondo è più fabulistico, più condizionato anche da elementi mitologici che si ritrovano pure nelle culture circonvicine ad Israele, per esempio in Mesopotamia.
Si potrebbe persino dire che sono due generi diversi. Gen 1 è piuttosto un racconto di creazione, mentre Gen 2 è un racconto di origine, perché è lì che si dà particolare rilievo alla creazione dell’uomo. Sta di fatto però che sia Gen 1 che Gen 2 raccontano, dicono, proclamano Dio come Creatore e dicono che tutto ciò che esiste è stato creato da Dio e che l’uomo, creatura ultima, definitiva, culmine di tutta la Creazione, è creato da Dio e posto in una relazione di dominio nei confronti del mondo. Vedremo che questo è il senso fondamentale che si ripete nei due racconti. In modo diverso i due testi dicono la stessa cosa: Dio è Creatore, il mondo è creato da Dio, il mondo creato da Dio è buono. L’uomo è creato da Dio, deve dominare la terra e anche l’uomo è buono.
E’ significativo che gli autori, per dire questo, lo dicano due volte. E’significativo perché se loro, per dire la stessa realtà di Creazione, (insistendo soprattutto sulla dipendenza da Dio, perché è Lui il Signore e Creatore) la raccontano due volte, secondo due modalità completamente diverse, è evidentissimo che non intendevano dire che il modo con cui loro raccontano la Creazione è il modo con cui di fatto essa è avvenuta. Se loro avessero voluto intendere che uno, leggendo Gen 1, deve pensare che la Creazione è proprio avvenuta così, in sette giorni, non avrebbero messo subito dopo Gen 2, in cui invece si racconta che i sette giorni non c’entrano niente. E’ chiaro dunque che ci vogliono dire che non è la modalità della Creazione che a loro interessa, e non è quella da prendere come il modo con cui veramente è avvenuta. A loro non interessa nulla di dire il modo in cui è avvenuto, tanto è vero che raccontano due modi diversi.
Quello che interessa all’autore sacro, non è ricostruire i fatti della Creazione, non è fare una cronaca della Creazione, nel suo svolgersi temporale, ma indicare qual è il senso del Creato e dell’uomo e il senso quindi dell’essere dell’uomo in relazione con Dio che è il Creatore. Quindi noi leggiamo questi testi per andare a cercare il senso del mondo e dell’uomo in relazione con Dio. In Gen 1 a questo proposito è interessante vedere che modalità concettuali vengono utilizzate per parlare di Dio come Creatore e del mondo come Creato.
Una prima modalità concettuale che utilizza il testo sacro è in riferimento al fatto che Dio come Creatore è qualcuno che fa, agisce, opera. Si dice che Dio fa il firmamento, che fa le due luci grandi, che fa le bestie selvatiche, che fa l’uomo, ecc. Si continua a dire che Dio fa. Si dice che Dio crea (un altro modo di agire). Crea il cielo e la terra, crea i mostri marini ecc. Si dice che Dio pone. Pone gli astri in cielo. Dio dà l’erba come cibo agli uomini e agli animali. Gen 1 presenta il creare di Dio come un fare da parte di Dio. Ora questi testi, siccome non ci vogliono dire come davvero è successo, ci vogliono piuttosto indicare il senso; questo è significativo.
Tutta la Rivelazione biblica e l’esperienza che l’uomo fa all’interno del proprio esistere ci mostrano una fondamentale tendenza degli uomini a fare, con il rischio continuo di pensare di essere loro, coloro che veramente fanno. Dunque Gen 1 che insiste così tanto sul fare di Dio ha una forte intenzionalità anti-idolatrica, perché mette in guardia invece da quel fare dell’uomo che diventa idolatrico, perché uno crede di essere lui a fare, a costruire la propria esistenza, le sue cose ecc.
Mette in guardia da questa tentazione idolatrica del fare, che non è solo quella di pensare di essere io che faccio, ma che addirittura si esplicita nel farsi poi gli idoli. E quindi nell’essere noi uomini che facciamo il nostro Dio, costruendo l’idolo, o facciamo, di noi stessi, Dio. E questo fare l’idolo - che attraversa tutta la Scrittura - è il problema fondamentale dell’uomo che continuamente si fa degli idoli. E non dobbiamo necessariamente pensare agli idoli intagliati nel legno o nella pietra, alle statuine, ma a certe concezioni del vivere, a certe dimensioni del vivere: il successo, la salute, la bellezza fisica, i soldi. Ma ancor più quel costruirci mentalmente il nostro Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, per cui noi non solo facciamo del denaro o del successo un idolo, ma ci costruiamo una nostra immagine di Dio e in questo modo trasformiamo Dio in idolo.
Perché quello non è più il Dio che crea l’uomo a sua immagine e somiglianza, ma il Dio che l’uomo crea a propria immagine e somiglianza e dentro questa immagine cerca di ficcarci a forza Dio. Ma quello che può essere racchiuso dentro dei limiti, dei concetti, delle immagini, ovviamente non è più Dio, ma l’idolo. Gen 1 comincia subito a spazzare via questo e a dire: attenti, il vero fare è quello di Dio. E quando l’uomo, invece di fare in obbedienza a Dio e riconoscendo che chi davvero fa è Dio, si mette a fare lui, allora guardate che quello che succede è l’idolatria, il totale non senso.
Sapete che esistono nella Bibbia due stesure, due tradizioni che raccontano del decalogo, una in Es 20, l’altra in Dt 5. Sono due testi assolutamente uguali, con delle piccole differenze. Una differenza è la motivazione del comando del sabato:
“Osserverai il sabato e quindi nel giorno di sabato non farai nessun lavoro, né te, né tuo figlio, né tua figlia, neppure il tuo schiavo e neppure i tuoi animali”.
Dt 5 dà questa motivazione: perché così tu ti ricordi che sei stato schiavo in Egitto. Dt dice che il sabato serve a fare memoria della liberazione dalla schiavitù che Dio ha operato nella tua vita. Tu, che sei stato liberato, devi diventare il liberatore. Tu, che sei stato liberato dalla schiavitù, nel giorno di sabato devi porre questo gesto simbolico fondamentale che è quello di liberare il tuo schiavo non facendolo lavorare il giorno di sabato. Pensate alle conseguenze se venisse applicato seriamente non semplicemente al sabato, ma come struttura di vita e di rapporti con gli altri.
In Es 20 invece la motivazione è: perché per sei giorni Dio ha creato e il settimo giorno si è riposato. Dunque si fa riferimento proprio a Gen 1. Questo è particolarmente significativo a proposito della concezione del fare come prospettiva anti-idolatrica, perché connesso con il comando del sabato ci si dice: guarda che quello che davvero fa è Dio. Però tu anche sei chiamato a fare, quindi tu per sei giorni devi lavorare, ma il settimo giorno devi, attraverso quel non-fare, proclamare e testimoniare che l’unico che davvero fa è Dio, e non solo nel giorno di sabato quando tu non fai, ma anche negli altri giorni in cui tu fai. Ma il tuo fare, il tuo lavorare, il tuo creare (perché noi di fatto, interagendo con il mondo creiamo cose nuove, trasformiamo un albero in un tavolo) è un collaborare alla creazione di Dio, in obbedienza a Dio, in dipendenza da Dio, e nell’assoluta consapevolezza che chi davvero crea è Lui. Noi possiamo creare nella misura in cui creiamo insieme a Lui, e dunque secondo i suoi criteri, secondo il suo modo di pensare, in obbedienza a Lui. Abbiamo allora questo primo elemento; quando Dio crea, fa.
Seconda modalità concettuale che viene utilizzata per dire che Dio è il Creatore: si dice che quando crea il mondo Dio separa le cose. Separa la luce dalle tenebre. Separa le acque che sono sopra il firmamento dalle acque che sono sotto il firmamento. Fa emergere la terra dal mare (quindi li separa). Poi si dice che ogni specie vegetale fa il seme secondo la sua specie. Quindi è tutto distinto, tutto separato. Anche gli animali generano ognuno secondo la sua specie. In altre parole si dice che la creazione è l’uscita dalla confusione, che infatti è il caos primordiale, quell’acqua su cui c’è il grande vento, o, se volete, lo Spirito che aleggia. Il caos, ciò che è informe, l’acqua in cui tutto è mescolato, la confusione.
La creazione, dice Gen 1 è uscita dalla confusione. Perché Dio distingue e separa. Se questo è ovvio, ha però delle conseguenze serie a livello antropologico. E’ ovvio perché, per esempio, un foglio di carta per esistere deve essere distinto da un altro foglio. Non dico solo che un orologio deve essere distinto da un tavolo, ma che due orologi identici, per esistere, devono essere diversi, separati, perché sennò non ce ne sono due, ma uno solo. Un foglio di carta deve essere distinto da un altro, perché altrimenti uno dei due non c’è più. Questo è talmente ovvio che noi ce lo dimentichiamo, ma è assolutamente determinante dal punto di vista antropologico, perché vuol dire, e Gen 1 ci aiuta in questo, che l’uomo deve prendere coscienza che per esistere, deve accettare di essere diverso dagli altri e perciò deve accettare che gli altri siano diversi da sé.
Perché se io non accetto la diversità dell’altro, io non esisto più, perché sono l’altro o l’altro è me. Ma perché io e l’altro possiamo esistere, e si possa entrare in dialogo e in comunione, bisogna necessariamente che siamo separati, diversi, e che questa diversità venga accettata e riconosciuta. Altrimenti è annullamento, plagio, non esistenza. Questo è vero nei confronti degli altri uomini con tutto ciò che questo comporta di accettazione della diversità, del non voler a tutti i costi che l’altro sia come vuoi tu e come decidi tu. Vuol dire nei rapporti di tipo genitoriale, sia secondo la carne che secondo lo spirito, accettare che tuo figlio sia diverso e quindi non pretendere che diventi ciò che tu avresti voluto essere, l’immagine che tu hai di te o che a tutti i costi vuoi avere di lui, perché lui è lui e tu sei tu.
Vuol dire dunque capire che non c’è comunione possibile se non c’è anche assunzione di una qualche dimensione di solitudine. Perché dire che siamo diversi vuole anche dire che in qualche modo siamo soli. E che io solo posso fare certe esperienze. Se io mi ammalo, solo io sto male e quando muoio posso morire solo io. Se sono contenta sono io ad essere contenta. Certe cose si possono condividere, altre no, ma puoi condividere nella misura in cui sei soggetto e quindi in cui accetti anche una certa dimensione di solitudine. Che è ciò che permette la comunione. Perché se io non accetto di essere io e quindi non accetto anche la mia identità e la mia solitudine, non posso essere in comunione.
Ma questo, che è vero nelle relazioni con gli uomini, è ancora più vero nella relazione con Dio. Gen 1, facendo il discorso della separazione, ci dice: attenti, non solo dovete accettare di essere diversi, ma dovete accogliere questa fondamentale, assoluta diversità fra voi e Dio. Bisogna che l’uomo accetti di essere diverso da Dio, di non essere Dio e che Dio è diverso dall’uomo e che quindi non è come tu vorresti che fosse. E c’è qui tutto il cammino della conversione che è un cammino immenso. E tutte le volte che noi usciamo da questa distinzione, tutte le volte che noi non accettiamo la nostra diversità e soprattutto la diversità di Dio, la Creazione ripiomba nella confusione, nel caos.
E questo è assolutamente tipico del racconto di Genesi per il fatto che qui, in Gen 1, si dice che Dio separa, separa le acque di sopra da quelle di sotto. E quando invece il peccato - che è confusione, che è non accettare la diversità di Dio, l’obbedienza a Dio, la dipendenza, che è il voler fare come ti pare, il diventare tu Dio - raggiunge il culmine, che cosa succede? Le acque di sopra non rimangono più separate dalle acque di sotto: è il diluvio, il caos, la de-creazione. Il peccato fa ripiombare il mondo nel caos distruggendo la Creazione. Solo che Dio è più grande anche di questo e su quelle acque che ormai sono confuse, su quel grande caos che è il diluvio fa galleggiare l’arca di Noè. La vita continua, la fedeltà di Dio continua. Dio perdona.
Terza modalità concettuale importante che troviamo in Gen 1: il creare di Dio è fatto attraverso la parola. Non solo fare, non solo separare, ma anche parlare. Dio dice e le cose sono. “E Dio disse: Sia la luce! E la luce fu”. Per dieci volte in Gen 1 si dice: E Dio disse. E dieci è un numero significativo. Perché se queste sono le dieci parole della Creazione, immediatamente a chi legge vengono in mente le dieci parole del Decalogo. E il rapporto c’è. Perché come è attraverso le dieci parole di Dio che il mondo esiste, così è attraverso l’obbedienza alle dieci parole del decalogo che l’uomo può davvero esistere come uomo.
Dio dice e le cose sono, poi Dio le chiama - altro parlare! E voi sapete che dare il nome alle cose è segno di potere, di signoria, di dominio sulle cose. Perché il nome, nella mentalità biblica, non è semplicemente un modo convenzionale con cui si indica una realtà, ma rivela il senso profondo di quella realtà. Per cui chiamare qualche cosa vuol dire che tu conosci il segreto di quella cosa, lo possiedi e dunque nel momento in cui tu dici come si chiama tu stai esercitando il tuo potere, perché tu sai come è e sei tu che gli dici come è.
Per Dio questo è ancora più vero, perché il suo parlare fa, perché il suo è un parlare efficace. Non si tratta solo di nominare, di dire: “Questo è un bicchiere”. Nel momento in cui io dico: “questo è un bicchiere”, riconosco che questo è un bicchiere, ma se lo dice Dio, egli crea questo bicchiere dicendo come si chiama.
Dio dice, Dio chiama le cose e dà il nome. E Dio benedice. Ecco la grande parola definitiva della creazione di Dio, la benedizione, che compare solo negli ultimi tre giorni della creazione, cioè solo quando compare la vita. Compaiono i pesci, gli uccelli, gli animali e l’uomo. Quando comincia la vita lì allora c’è anche la benedizione. L’idea che loro avevano era che i vegetali non fossero vivi. Il vivente è per definizione uno che respira e che si muove. La vita comincia con gli animali e dunque è con l’inizio del quinto giorno che comincia anche la benedizione.
Ed è una benedizione che dice che la vita in quanto vita e in quanto vita benedetta è vita straripante, vita che si espande, che si moltiplica: “Crescete e moltiplicatevi”. Anche questa dimensione del creare, secondo Gen 1, è assolutamente determinante per la vita dell’uomo e del credente in particolare, se voi pensate che tutto il nostro rapporto con Dio passa attraverso la mediazione del rapporto con la parola. Con la parola di Dio e poi con quell’ultimo definitivo mediatore che è addirittura il Figlio stesso di Dio, il Logos che si fa uomo.
Tutto questo, dice Gen 1, avviene in sette giorni. Per sei giorni Dio crea e il settimo giorno smette di creare e si riposa. Questo anche è significativo perché sottolinea la dimensione di assoluta libertà e di assoluta gratuità da parte di Dio nell’opera di creazione. In altre parole Dio non è necessitato a creare, perché infatti comincia e poi smette. Smette quando l’opera è compiuta, però smette. Il che vuol dire che Dio non deve necessariamente creare, per cui potrebbe continuare a creare indefinitamente perché è costretto a farlo. Lui liberamente e gratuitamente decide di creare e smette quando la sua opera è giunta a compimento.
E nel momento in cui smette, ecco il sabato, c’è quel riposo di Dio che è il godimento davanti a tutto ciò che ha fatto. Alla fine di ogni giorno di creazione il testo biblico dice: Dio vide che - di solito noi traduciamo così - era “cosa buona”. In ebraico dice: ki tob. Tob vuol dire “buono”, ma anche “bello”. Ed è questa l’idea: “E vide che (era) buono e bello, ciò che aveva fatto”. C’è proprio il godimento, il compiacersi di Dio per ciò che ha fatto.
Ma alla fine di tutto il testo biblico cambia la formula e invece di dire solo che era buono e bello, dice che era molto buono e bello. E questo è il senso del sabato. L’esplosione della bellezza e della bontà della creazione di Dio, di cui Dio stesso gode, e di cui Dio fa dono all’uomo perché anche l’uomo ne goda entrando anche lui nel sabato. Allora l’uomo è l’ultima opera di creazione, fatto nel sesto giorno, ma per poter entrare nel settimo, per poter entrare in quella dimensione di godimento del creato che è molto buono. A questo serve l’osservanza del sabato, per poter celebrare questo Dio della creazione come Dio buono che fa le cose buone, delle quali si può godere senza paura perché: “Tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1Cor 3,22-23).
In questo senso, se si accetta il creato dalle mani di Dio, riconoscendo Dio come Creatore, quindi facendo il sabato, allora davvero tutto è nostro. Perché il mondo che il sabato celebra è il mondo bello e buono del Dio bello e buono.
All’interno però di questa scansione settenaria, di questa settimana di Creazione, voi avrete notato che c’è una apparente anomalia. Perché si dice che il primo giorno Dio disse: “Sia la luce! E la luce fu, e vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina. Primo giorno”. Dopo, però, è solo al quarto giorno che Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte e fece le due luci grandi, il sole e la luna e poi anche le stelle e le pose nel firmamento”.
Uno allora può pensare: “Non mi tornano i conti, perché se ha creato la luce il primo giorno, deve necessariamente aver creato il sole e la luna il primo giorno, perché sennò come fa ad esserci la luce? E allora che succede al quarto giorno?” - fermo restando che gli autori sacri qui non vogliono ricostruire quello che è cronologicamente avvenuto, quindi l’incongruenza a loro non interessa, perché non sono minimamente interessati ad una congruenza temporale, ma ad indicare il senso, quando mettono il sole e la luna a metà settimana.
Perché il quarto giorno è il mercoledì, partendo dalla domenica. Il giorno degli astri è a metà della settimana. Se lo mettono lì è perché vogliono indicare qualche cosa degli astri, che è diverso dal semplice illuminare il giorno come fa il sole così che ci siano il giorno e la notte. In altre parole, quando Dio il primo giorno crea la luce, crea il tempo cosmico, questo tempo indefinito e indistinto che è un semplice alternarsi di giorno e notte e basta. Non c’è alcuna possibilità di stabilire delle cesure, di mettere delle differenze. Tra l’altro guardate che anche Israele capiva che la luce veniva dal sole e di giorno c’era la luce per questo. Ma non c’erano i fanali e di notte c’era comunque tanta luce. La luna e le stelle fanno luce. Senza luce elettrica, in una notte di luna piena tu puoi leggere un libro, perché la luce c’è.
Quindi quando si parla di luce e tenebre non necessariamente ci si riferisce al sole e alla luna, che vengono dopo, a metà settimana, per indicare che hanno una funzione diversa, non semplicemente l’alternanza cosmica indefinita, ma, come dice il testo: “Servano da segni per le stagioni e per i giorni e gli anni”. Il sole e la luna non sono più il tempo cosmico indistinto, ma l’inizio e quindi la trasformazione del tempo cosmico in tempo storico.
Con il sole e con la luna si possono contare i mesi, gli anni, si possono distinguere le stagioni. Guardando la luna tu sai quando è il tempo di seminare o di mietere e, soprattutto, guardando la luna tu sai quando è il momento di celebrare le feste. Gli astri al quarto giorno sono l’inizio del tempo umano e di quel tempo sommamente umano che è il tempo liturgico, perché è il tempo che mette in relazione l’uomo con Dio attraverso le feste. E’ per questo, credo, che è solo dopo la creazione degli astri, quindi solo dopo che il tempo è diventato umano, che ci sono i giorni della creazione della vita e quindi poi dell’uomo come culmine degli esseri viventi. Si comincia prima con i pesci e gli uccelli, poi gli animali della terra e poi l’uomo.
Notate però una cosa assolutamente paradossale: l’uomo viene creato come culmine, l’ultima creazione, la più importante, l’ultimo evento creativo di questa sequenza di creazioni dei viventi. Ma l’uomo nonostante questo e nonostante sia portatore di questo assoluto mistero che è il fatto di essere fatto ad immagine e somiglianza di Dio, non ha un giorno di creazione per sé. Viene creato il sesto giorno insieme agli animali della terra. I pesci e gli uccelli hanno un giorno per loro, l’uomo no.
Questo è paradossale: l’uomo, immagine di Dio, condivide lo stesso giorno di creazione con gli animali e condivide con gli animali lo stesso cibo, perché si dice che Dio dà da mangiare, sia all’uomo che agli animali, l’erba verde. Quindi l’uomo è come Dio, è simile a Dio, perché è a sua immagine, ma è come gli animali, è simile agli animali, perché è fatto nello stesso giorno, mangia lo stesso cibo e, badate, ha la stessa benedizione degli animali: “Crescete e moltiplicatevi”.
Poi per l’uomo la benedizione cambia. Si aggiunge: “E dominerai la terra”. Perché l’uomo è diverso dagli animali, ma è uguale agli animali. Questo è il paradosso che noi ci portiamo dentro e in qualche modo rende così complicato vivere, perché noi siamo chiamati a vivere secondo questa doppia dimensione senza mai dimenticarne una. Esseri animali e insieme esseri divini. Ed è estremamente complicato tenere insieme queste due cose, per cui la tentazione continua è quella di semplificarle dicendo o: “L’uomo è animale. Nasce e muore ed è finita là. Tutto si esaurisce in questi giorni che ci vengono dati, cerchiamo di fare del nostro meglio, ma non ci facciamo illusioni, siamo come gli animali. Pur capaci di gestire il mondo, di costruirci le nostre esistenze, persino capaci di far nascere i bambini in provetta. Però anche quel bambino che abbiamo fatto nascere in provetta muore, è un animale pure lui.” L’altra tentazione è quella di dire: “Noi siamo come Dio”. Poi si fa prestissimo a togliere quel come e la frase diventa: “Noi siamo Dio. Infatti noi creiamo l’uomo, facciamo nascere la vita, creiamo le cose, possediamo la nostra vita, siamo i signori della nostra vita. Noi siamo Dio.”
Tutte e due queste affermazioni sono false. E’ vero che siamo animali, ma non solo animali. E’ vero che siamo come Dio, ma non solo divini e quindi non siamo Dio. Il nostro compito è quello di tenere insieme questa duplice realtà, vivendo fino in fondo la nostra vocazione divina, ma senza mai dimenticarci che siamo stati fatti nello stesso giorno degli animali e quindi senza mai dimenticarci che non siamo Dio, ma solo fatti ad immagine di Dio.
E che quindi anche tutto il nostro potere, che pure fa parte della benedizione che riceviamo: “Dominate la terra”, è però un comando che riceviamo, è un compito, non una nostra prerogativa che noi possiamo gestire come ci pare. E’ vero, noi siamo i signori del mondo, ma solo se riconosciamo che il vero signore è Dio. Eccolo il comando del sabato. Ecco cosa vuol dire entrare nel sabato. Dove è vero che noi dominiamo la terra, ma possiamo dominarla solo se noi capiamo che questo essere signori della terra va vissuto ed esplicato in obbedienza a quell’unico Signore che ci dona e ci comanda di essere signori della terra.
Va in questa stessa linea il fatto che l’uomo e gli animali mangino lo stesso cibo. Mangiare qualche cosa non è un atto neutro, ma dalla forte valenza simbolica. Perché, quando noi mangiamo, cosa facciamo? Prendiamo qualcosa che è al di fuori di noi, e che quindi non siamo noi, e lo facciamo diventare nostro così che quello diventi la nostra possibilità di vita. Questo significa che anche nel gesto semplice di mangiare un pezzo di pane noi stiamo simbolicamente dicendo che la vita non ci appartiene, che non nasce da noi, che non siamo noi il principio della nostra vita.
Tanto è vero che per poter vivere noi abbiamo continuamente bisogno di prendere la vita da qualcuno che ce la dà e di mangiarla. Io ogni tanto ripeto ai miei studenti: “Ragazzi, se volete contrastare il vostro delirio di onnipotenza, andatevi a fare un bel panino con la mortadella. Perché se voi mangiate il panino, voi state dicendo che da soli non vivete, avete bisogno di quello per vivere. Non è vero che siete onnipotenti. Pensate, avete bisogno di un panino!”.
Tra l’altro qui siamo nell’Antico Testamento e io sto citando il suino, un abominio. L’ebreo direbbe: “Non è vero che quello ti fa vivere, per questo non lo mangi. Perché ciò che ti fa vivere è sì quello che tu mangi, ma siccome quello che tu mangi è dono di Dio e la vita ultimamente è dono di Dio e ultimamente non è il pane che ti fa vivere, ma Dio che ti dona di vivere. Allora per poter dire questo, tu non mangi quello che ti pare, non mangi qualunque cosa ti capiti fra le mani. Ma mangi solo i cibi puri, cioè mangi facendo del tuo mangiare un atto di obbedienza.
Perché è chiaro che a Dio, posso immaginare, non gliene importi assolutamente niente se noi mangiamo la mortadella piuttosto che una fettina di pollo. Ma perché allora – direbbe un ebreo - noi mangiamo il pollo e non la mortadella? Perché in questo modo noi significhiamo che il nostro mangiare è fatto in obbedienza al Signore della vita. E è questo il nostro modo per dire che Lui è il Signore della vita e che ciò che ci fa vivere non è solo il pane, ma “ogni parola che esce dalla bocca di Dio”, come dice Dt.
Ed è per questo che il buon ebreo, e anche il buon cristiano, ogni tanto digiuna. Per poter dire che noi viviamo sì del pane, ma che ultimamente non è quello che ci fa vivere, ma è Dio. Noi dobbiamo mangiare per vivere, ma ogni tanto dobbiamo porre il gesto simbolico del digiuno per dire che non è il pane solo che ci fa vivere, ma c’è altro. Se mangiare è questo, pensate quanto è importante.
Pensate a che cosa importante è mangiare insieme. Perché vuol dire condividere la vita. Ecco perché l’Alleanza al Sinai finisce con un banchetto: condivisione di vita. Ecco perché gli scribi e i farisei si scandalizzavano così tanto del fatto che Gesù mangiasse con le prostitute e i peccatori: condivisione di vita. Se il mangiare ha questa valenza così importante, ecco che Gen 1 dice che nel progetto originario di Dio, questo atto di assunzione della vita era fatto attraverso il nutrimento vegetale. Dunque attraverso un nutrimento che non è vita, perché i vegetali non erano considerati esseri viventi, e animali e uomini mangiano cibo vegetale.
Cosa vuol dire? Che nel progetto originario di Dio, la vita per crescere, per esistere, per nutrirsi, non aveva bisogno di uccidere altra vita. Il cibo vegetale vuol dire che io posso nutrire la mia vita senza uccidere esseri viventi, che è ciò che invece succede dopo il diluvio, quando Dio prende atto che la violenza si è instaurata e allora dice: “Il tuo cibo saranno gli animali, gli animali si mangeranno tra di loro, ecc.”, dicendo in questo modo che c’è ormai questa dimensione di violenza che non c’era nel progetto originario di Dio. Questo vuol dire che quel compito che secondo Gen 1 l’uomo riceve, di dominare sulla terra e sugli animali, è un compito che l’uomo deve assolvere come Dio, ad immagine di Dio, quindi secondo quell’amore per la vita, quel rispetto per la vita, quella mitezza che è tipica di Dio.
Quindi dominare sul mondo, sugli animali e sulla vita da parte dell’uomo, deve essere fatto nell’assoluto, totale rispetto della vita e fatto in modo tale che la vita possa crescere ed espandersi in piena libertà, senza essere violentata dalla pretesa onnipotente e quindi assolutamente folle dell’uomo. Non dimentichiamo che Gen 1 nasce in ambiente di morte, perché nasce quando Israele è in esilio, quando è stato deportato e vive questa esperienza di morte reale, non solo perché li stanno decimando, ma di quella morte ancora più tragica che è non capire più cosa sta succedendo, e soprattutto non capire più che fine ha fatto Dio.
Perché quando Israele viene portato a Babilonia, è come se avesse perso Dio. Perché Dio aveva fatto delle promesse, la terra, il re, il tempio, e tutto è finito. Non c’è più niente ed Israele si domanda: “Non c’è più niente, ma Dio c’è ancora?” Che è il momento della crisi, del buio, del dolore, che ogni credente prima o poi attraversa quando sembra che i conti non tornino più. Sembra che Dio dopo averti promesso qualcosa poi te la tolga. In questa situazione nasce questo grandioso inno alla vita che è Gen 1. Che, nella crisi della fede, dentro la morte, dice: “No! Dio c’è, è il Dio della vita, c’è da sempre e quindi per sempre ed è il Dio bello e buono che fa cose belle e buone”. E allora si può anche attraversare la morte, perché al di là della morte c’è la vita, quella per sempre, bella e buona.
Genesi 2
E’ un testo diverso da Gen 1. Sono comprovati i rapporti che Gen 2 e Gen 3 hanno con miti mesopotamici e altre culture circonvicine. Ma quello che a noi interessa soprattutto è il senso, la rivelazione di cos’è l’uomo, cosa è Dio e cosa è il mondo. E’ questo che questi testi ci vogliono dire.
Vediamo quali sono gli elementi fondamentali per poi soffermarci su quello che è l’essenziale di Gen 2, cioè la creazione dell’uomo. Noi abbiamo visto che in Gen 1 l’uomo è il culmine di tutte le opere create, quindi è l’opera più importante in quanto l’ultima, di lui però non si parla molto. Qui invece tutto è incentrato sulla creazione dell’uomo, quindi il discorso antropologico si fa molto più ampio, molto più preciso, senza però modificare il messaggio fondamentale, pure se detto in altro modo.
Abbiamo visto che in Gen 1 l’uomo è portatore di questo mistero, di questo paradosso, di essere contemporaneamente immagine di Dio e animale. In Gen 2 noi abbiamo gli stessi elementi. Si dice che l’uomo è la prima opera di creazione, dunque la più importante. Nell’altro testo si diceva che era l’ultima e quindi la più importante, perché la visione era: si fanno le cose e tutte sono in vista dell’ultima che è l’uomo e l’uomo è addirittura in vista del sabato. La prospettiva è: prima si dice tutto quello che serve per l’uomo e poi si dice l’uomo, che quindi è il centro e il culmine.
In Gen 2 si dice la stessa cosa, semplicemente spostando la prospettiva e dicendo: siccome l’uomo è il più importante ed è il culmine, allora l’uomo è fatto per primoIn Gen 2 come in Gen 1 l’uomo è al centro, l’opera più importante e portatore anche qui di un paradosso.
E’ signore del giardino. Il giardino viene fatto appositamente per lui, ed è un giardino in cui ci sono i fiumi, il che vuol dire che è un giardino in cui c’è la vita in pienezza e in sovrabbondanza. Non ci dimentichiamo che Israele, la terra di Palestina, è una terra arida, secca, perennemente in lotta per avere l’acqua che fertilizzi la terra. Immaginare un giardino in cui ci sono quattro fiumi che riempiono d’acqua tutta la terra, e non con un’inondazione che distrugge tutto, ma bracci di fiumi, acqua incanalata per l’irrigazione, vuol dire che questa è una terra che ha in sé il suo tesoro più prezioso, cioè l’acqua che fa vivere, che la rende fertile.
In più è una terra ricchissima anche proprio di cose preziose, convenzionalmente considerate preziose, perché è una terra di oro, è una terra di pietre preziose, c’è la resina odorosa, quindi è una terra piena di cose belle e ricche e l’uomo viene messo qui in questo giardino fatto apposta per lui perché possa custodirlo e coltivarlo, per esercitare su questo giardino l’opera di signoria, di dominio. E’ lui che fa sì che questo giardino possa dare la vita coltivandolo, è lui che lo custodisce, che decide cosa fare di questo giardino. E’ lui il signore, però è un signore che deve fare questo in obbedienza a Dio e senza sostituirsi a Dio perché è Dio che ha fatto il giardino ed è Dio che lo mette nel giardino ed è Dio che ce lo mette perché lo custodisca e lo coltivi, come in Gen 1 era Dio che dava il comando: “Governa la terra” .
Ma questo uomo, signore di questo giardino pieno di ricchezza e di vita, è però fatto di polvere. Di là si diceva: a immagine di Dio però come gli animali, di qua si dice: signore del giardino e quindi luogotenente del giardino, ma fatto di polvere. Tra l’altro di quella stessa polvere di cui poi, secondo il racconto, vengono fatti gli animali. In Gen 1 l’uomo e gli animali hanno lo stesso giorno, in Gen 2 la stessa materia. Vedete che quella dimensione che io chiamo paradossale è presente in questo testo come nell’altro.
Tenete anche presente che Gen 2,7 di solito viene tradotto così: “Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita”. Letteralmente però è: “E plasmò, il Signore Dio, l’uomo polvere dalla terra”. Plasmò l’uomo polvere. Questo polvere può essere interpretato come un accusativo di materia e allora si vuole intendere “con la polvere”, però può essere semplicemente e, probabilmente, un’apposizione: plasmò l’uomo come polvere. Quindi l’uomo non è solo fatto con la polvere, è polvere.
E questo poi torna in molti altri testi: “Polvere sei e polvere ritornerai”, ma polvere presa dalla terra (adamah), e qui c’è una tradizione ebraica molto bella di cui è testimone Rashi, famoso commentatore ebraico medievale, il quale riportando una tradizione molto più antica, dice che quando Dio ha creato l’uomo dalla terra, l’ha fatto prendendo la polvere da tutta la terra, dai quattro punti cardinali di modo che questo uomo, così plasmato da Dio, è un uomo che non appartiene ad una parte della terra, ad un settore della terra, ma alla terra intera. Implicando con ciò che tutti gli uomini sono fratelli perché vengono tutti dalla stessa madre e tutti ritrovano la stessa madre morendo, per cui in qualunque luogo l’uomo muoia, troverà sempre una terra che lo conosce, perché lui è stato fatto dalla terra che viene da ogni luogo.
Quindi in qualunque posto lui vada la terra lo riconosce e, ovunque si trovi, la terra–madre sarà sempre pronta ad accoglierlo. Vedete come nell’identità di prospettiva, ci sia una differenza di formulazione. Non c’è: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”, qui c’è Dio che prende la terra e la plasma. Si usa un verbo che indica di solito l’attività del vasaio che plasma la creta per fare le sue opere artigianali, con tutto quello che ciò comporta dell’idea del lavoro di Dio che non solo è un lavoro bello, importante, fatto da chi lo sa fare, che richiede abilità, competenza, estro creativo. E’ un lavoro che richiede anche fatica, coinvolgimento emotivo, che sporca le mani.
Perché il vasaio nel fare la sua opera si sporca, fa le cose con passione e quando poi alla fine guarda il suo vaso dice che è proprio molto bello. Proprio come Gen 1 dice che Dio fa alla fine dell’opera creativa. La sintesi di questa dimensione paradossale dell’uomo che troviamo qui come in Gen 1, per cui l’uomo è polvere, però è signore del giardino e ha in sé l’alito di vita che gli viene da Dio, è esplicitata in Gen 2 (e non in Gen 1) in quel comando che Dio dà all’uomo:
E comandò il Signore Dio all’uomo, dicendo: “Di tutti gli alberi del giardino tu potrai senz’altro mangiare, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male tu non dovrai mangiarne, perché nel giorno in cui ne mangiassi, certamente moriresti (Gen 2,16-17).
Noi qui abbiamo un comando da parte di Dio. Che potrebbe anche sembrare un comando arbitrario, fatto da Dio solo per tenere in qualche modo l’uomo al proprio posto, mettere dei limiti, dire: “Io ti ho fatto, ti ho dato il giardino, tu sei signore del giardino, però un albero io ti impedisco di toccarlo, così capisci chi è che comanda qui! E vediamo se obbedisci”.
Dio mi dà il giardino e poi mi dice: “Quello non lo mangi”. Per carità, il giardino è suo e fa quello che gli pare, però perché mai non dovrei mangiarlo? Notate bene che qui di mela non si parla, la mela non c’entra nulla, ma l’interpretazione che potrebbe venirci la voglia di dare a questo comando è: “Dio mi dà un comando tanto perché sia chiaro che Lui è Dio ed io sono uomo e che qui comanda lui e alcune cose non le posso fare”. Non è così che va capito il rapporto dell’uomo con Dio e anche la prova che l’uomo deve attraversare nel suo rapporto con Dio. E certamente non è così che va capito il ribadire da parte di Dio la propria realtà di Dio in rapporto invece alla realtà dell’uomo che è una realtà diversa da quella di Dio (il concetto di separazione che abbiamo visto in Gen 1).
Quando Dio dà all’uomo il comando di non mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male, gli sta in qualche modo indicando la strada per poter vivere pienamente e in piena felicità la sua realtà di uomo. Perché cosa vuol dire mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male? Scomponiamo la frase. Abbiamo detto che mangiare vuol dire prendere una cosa, assimilarla e farla tua. Conoscenza nel mondo ebraico non vuol dire sapere una cosa, o distinguere tra una cosa e l’altra. La conoscenza è qualcosa di estremamente profondo che si trova a dei livelli misteriosi di profondità di rapporto tra chi conosce e chi è conosciuto, in cui si entra in una relazione di mutuo donarsi e possedersi, in cui uno diventa in qualche modo origine dell’altro e viceversa. Tanto che è ben noto che il verbo conoscere è un eufemismo per indicare l’avere rapporti sessuali, per indicare quindi quel compenetrarsi uno nell’altro, possedere mentre ci si dona, mentre ci si lascia possedere ed entrare in una relazione talmente stretta per cui io adesso so tutto di te e tu sai tutto di me, io sono te e tu sei me e i due diventano uno.
Cosa significa conoscenza del bene e del male? Nel mondo biblico, quando si utilizzano due termini che sono contrapposti o che comunque sono l’uno all’inizio e l’altro alla fine di una serie omogenea, non si vogliono indicare quelle due cose che vengono dette, ma si vuole indicare tutta la serie. Quando si dice: “Dio creò il cielo e la terra”, si vuol dire che Dio ha creato tutto: il cielo, la terra, le acque di sopra, le acque di sotto, il mare, il firmamento, gli astri. Quando nel Dt si dice al buon israelita: “Guarda che tu ti devi ricordare le parole di Dio e dovrai meditarle, giorno e notte, e quando entri e quando esci, quando ti siedi e quando ti alzi”, non vuol dire che tu te le devi ricordare quando esci, poi scordartele, farti gli affari tuoi, e ricordartele quando rientri. Si dice “entrare ed uscire” per indicare tutta l’attività dell’uomo, uscire dalla casa, dalla città, dal grembo materno. E’ tutto il mondo dell’uscire, tutto il mondo dell’entrare e tutto quello che ci sta in mezzo.
Per cui quando si dice bene e male non si intende ciò che è bene e ciò che è male, non si intendono le due categorie etiche, per cui coscienza del bene e del male vorrebbe dire conoscere quello che è bene e conoscere quello che è male. Non è così, bene e male vuol dire tutto quello che è dentro la serie del bene e del male, ma abbiamo detto che bene è anche bello, quindi tutta la serie di bene-male, bello-brutto, felicità-infelicità, vita-morte, tutto quello che c’è dentro, e vedete che questo vuol dire la realtà intera. Allora dire che non si può mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male non vuol dire che tu non puoi appropriarti del conoscere ciò che è bene e ciò che è male. Anche perché se così fosse, allora l’uomo trasgredendo, siccome non ha ancora mangiato dell’albero della conoscenza del bene e del male, non potrebbe sapere che quello è male, perché non poteva conoscerlo.
Il vero discorso è: “Tu non puoi mangiare, cioè assimilare, la conoscenza, cioè il possesso, l’essere principio, origine, avere i segreti, di tutta intera la realtà in tutte le sue dimensioni materiali e spirituali. Tu non puoi diventare, assumere, strappare e far diventare tuo l’essere origine del Tutto”. Capite che quando Dio dice questo all’uomo non sta facendo altro che dire: “Guarda che tu sei uomo, non puoi essere Dio”. Viene detto sotto forma di comando perché è nel rapporto con la legge che l’uomo scopre l’alterità. Perché è nel rapporto con la legge che tu scopri che non ci sei tu solo e che esistono pure gli altri con i loro diritti e che tu li devi rispettare.
Il bambino crede di essere lui solo, tanto che addirittura c’è una fase in cui anche sua madre fa parte di lui; ma quand’è che il bambino diventa veramente consapevole della propria identità? Quando diventa consapevole che esistono gli altri. E come fa? Quando cominciano a dirgli: “No! Questo tu non lo puoi fare”. “Perché?” Se uno risponde: “Perché no!” è meglio che rinunci a fare il genitore, ma se invece uno gli risponde: “Non puoi perché vedi che c’è anche lui e questa cosa fa male a lui; e lui è come te e deve avere il tuo stesso giocattolo”, il bambino, attraverso la legge, quello che gli dicono il padre e la madre, scopre che al mondo non c’è solo lui, ci sono anche gli altri, che il suo spazio è limitato perché c’è lo spazio dell’altro che va rispettato. E’ questo che permette al bambino di crescere e di prendere coscienza di sé. E’ questo che fa diventare l’uomo adulto. Ed è la negazione di questo l’infantilizzazione di ogni adulto egocentrico.
Dio sta facendo questo. Attraverso forma di comando, per i motivi che abbiamo visto, sta dicendo all’uomo: “Tu sei uomo e questa è la tua verità e bisogna che tu ne prenda coscienza e la rispetti, perché solo così tu puoi essere davvero uomo e prendere coscienza della tua identità ed essere davvero in comunione con me”. Perché solo se mi riconosco diverso posso essere in comunione. Questo comando è offerta di verità e di comunione. Perché dico che qui è la sintesi del paradosso dell’uomo? Perché confrontandosi con questo comando l’uomo prende coscienza del proprio essere uomo, quindi prende coscienza del limite, fa esperienza di alterità, ma questo limite diventa apertura all’altro e quindi l’uomo capisce di essere polvere, ma capisce anche di essere immagine di Dio secondo Gen 1 e signore del giardino secondo Gen 2, perché il comando gli indica la via di quell’essere uomo, quindi di quell’accettazione di essere polvere che però lo mette in relazione e in comunione con Dio. Questo comando, secondo il nostro racconto, riguarda l’albero della conoscenza del bene e del male.
Ma nel nostro racconto, Gen 2,9, quando si descrive come è fatto il giardino, si dice:
E il Signore Dio fece germogliare dalla terra ogni albero bello da vedere, buono da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.
Quando descrivono il giardino, ci dicono che è pieno di alberi, e che c’è un albero della vita che sta in mezzo al giardino e un albero della conoscenza del bene e del male. Gli alberi sono due. E il fatto che ci siano due alberi pone qualche problema, perché l’albero della vita poi sparisce e si ritrova solo alla fine quando Dio mette il cherubino a bloccare la via, mentre invece per tutto il resto del racconto si continua a parlare dell’albero proibito.
Qui si tende a dire, da parte di alcuni studiosi, che in realtà c’è una convergenza di due diverse tradizioni. Una che parlava dell’albero proibito, che sarebbe quello della conoscenza del bene e del male, l’altra che risente dell’influenza dei miti mesopotamici dove si parlava dell’albero della vita e di un serpente che ruba la pianta. Il racconto – dicono - vuole parlare di un albero solo, l’albero proibito. Questo è quello che normalmente si dice e probabilmente non è falso, dico probabilmente perché questa faccenda delle tradizioni che confluiscono in uno stesso testo è una pura ipotesi e non si può provare perché noi non abbiamo le tradizioni a cui si farebbe riferimento. Anche ritenendo sufficientemente verosimile che qui siano state utilizzate due tradizioni diverse, quello che però poi è avvenuto è che nello scrivere le hanno utilizzate entrambe. O noi diciamo che a noi del testo biblico non ce ne importa nulla perché siamo interessati solo a quali tradizioni usavano gli autori, a qual è la tradizione migliore, ma allora non stiamo leggendo la Bibbia, stiamo facendo un’opera di ricostruzione letteraria, dal sentore fortemente archeologico oppure vogliamo leggere la Bibbia.
E la Bibbia è questa, che Israele ha assunto come testo ispirato e che la Chiesa ha ricevuto da Israele e che ha assunto e riconosciuto come testo ispirato e ci ha messo tra le mani perché alimenti la nostra fede. Se la Bibbia è questa bisogna tenersi quello che c’è scritto. Uno potrebbe dire che è solo un errore commesso unificando due tradizioni. Questo punto va chiarito. Non solo il testo della Bibbia è riconosciuto come testo ispirato e come tale è normativo, ma c’è una considerazione terra terra e più umana da fare, in aggiunta. Possibile che il redattore ultimo che ha scritto questo testo fosse così deficiente da non accorgersi che stava scrivendo che gli alberi sono due? O era sbronzo e vedeva doppio o era cretino. Perché se scrive: “C’erano tanti alberi, e c’era quello della vita che stava in mezzo al giardino (ti dice pure dove stava!), e poi quello della conoscenza del bene e del male...”. Possibile che uno sia così cretino? Lo sa che sta parlando di due alberi.
Al di là della professione di fede che io faccio dicendo che questo è il testo ispirato e a me interessa questo e del resto mi importa, ma solo nella misura in cui mi aiuta a capire questo, faccio un ragionamento più tranquillo dicendo che non potevano essere tutti cretini. Vogliamo dare un minimo di credibilità a questi che sapevano scrivere e scrivere bene? Se l’autore ultimo ha voluto mantenere entrambe le tradizioni, per qualche motivo lo avrà fatto. A noi adesso tocca il compito di tenerci due alberi e di capire perché sono due. Io la mia ipotesi ce l’avrei.
A me sembra che - e poi troveremo la conferma in Gen 3 - tenendo le due tradizioni, ammesso che di questo si tratti, il redattore ultimo ha messo in gioco qualche cosa di estremamente delicato oltre che di estremamente importante: il concetto di vita. Non gli bastava fare il discorso: “Dio ha dato il comando sull’albero della conoscenza del bene e del male e ha indicato all’uomo la via per essere veramente uomo”. Ha voluto mettere in gioco il discorso della vita dicendo che la vita di per sé non è proibita all’uomo. Perché l’albero proibito è solo uno.
L’autore biblico ha voluto chiarire che quando si dice che tu non devi mangiare dell’albero del bene e del male, tu non devi pensare che ti sia precluso l’esistere, ma che nella misura in cui tu accetti di non mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male, di non essere Dio e di vivere in obbedienza a Dio, allora puoi anche mangiare dell’albero della vita, allora la vita è tua, allora la vita la gestisci tu, allora sei tu il signore della vita, proprio come sei signore del giardino, ma sarai signore della vita come sarai signore del giardino, cioè accogliendo la vita come dono, rispettandola e vivendo la tua signoria nei confronti della vita in dipendenza e in obbedienza a Dio che è l’unico Signore della vita.
Che è quello che vi dicevo nel precedente incontro: “Tutto è vostro, se voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio”. Tutto è nostro se noi viviamo in obbedienza a Dio. La vita è nostra, non c’è da aver paura, la vita ci appartiene, se noi però non mangiamo dell’albero della conoscenza del bene e del male. Quindi se noi capiamo che, sì, questa vita ci appartiene, ma ci appartiene come dono che noi riceviamo e che dobbiamo continuare a rispettare e a vivere come dono senza mai appropriarcene e senza mai dire: “Questa è roba mia e ci faccio quello che mi pare”, perché questa è roba mia, ma è mia perché c’è Lui che me la dà, e quindi è mia mentre continua ad essere sua.
Ecco il punto, di nuovo un paradosso. E dunque io la gestisco in obbedienza e in radicale dipendenza da Dio. Perciò non mangio dell’albero della conoscenza del bene e del male. Perché io non mi sostituisco a Dio e perciò la vita si apre davanti a me in tutta libertà. Che è quella libertà somma che è la possibilità di vivere obbedendo a Dio. Perché secondo la prospettiva biblica libertà e obbedienza vanno insieme e sono praticamente la stessa cosa. Non c’è obbedienza possibile se non nella libertà e la vera libertà è di poter obbedire. A Dio, non agli uomini. L’uomo perciò diventa veramente signore del creato a tutti i livelli, solo se accetta di non essere lui il Creatore. Questo è ciò che viene detto all’uomo.
E qui bisogna che ci capiamo sui termini. In questo nostro racconto, per tutta la prima parte si parla di Adam. Questo termine in ebraico vuol dire fondamentalmente umanità, genere umano in senso collettivo. In senso individuale vuol dire persona umana. Quindi uomo, ma non maschio, uomo come persona umana in cui la specificazione sessuale è del tutto impropria e indifferente. Tanto che questo termine può addirittura essere usato come pronome indefinito: qualcuno, uno.
Diventa nome proprio di persona, quindi Adamo, solo in Gen 4,25. Questo è generalmente riconosciuto. Quindi quando noi diciamo Adam noi diciamo la persona umana. In questo racconto si dice che il Signore Dio plasmò Adam polvere del suolo, poi soffiò l’alito di vita e Adam divenne un essere vivente. Poi il Signore piantò un giardino e vi collocò Adam. Ci sono gli alberi, i fiumi e il Signore prese Adam e lo mise nel giardino e il Signore diede questo comando ad Adam... e poi il Signore Dio disse: “Non è bene che Adam sia solo”.
Vi ricordate che fa gli animali, Adam impone il nome agli animali, perché lui è superiore agli animali e poi Dio addormenta Adam, gli prende un lato, ne fa una donna (versetto 22), ’ishsha in ebraico, e la portò ad Adam e Adam disse: “Questa volta questa davvero è osso delle mie ossa e carne della mia carne, per questo si chiamerà ’ishsha perché da ’ish essa è stata tratta”.
Voi adesso dovete fare questo sforzo mentale di sostituire alla parola uomo che siete abituati a sentire nel racconto di Gen 2, l’espressione persona umana. E’ la persona umana che viene formata come polvere dalla terra. E’ la persona umana che riceve il comando, è la persona umana che non è bene sia sola. Notate che questo “non è bene” in ebraico è lo tob, lo vuol dire “non” e tob è lo stesso termine che abbiamo visto precedentemente, che significa “bello e buono”. Alla fine di ogni giorno di creazione Dio dice che ciò che è creato è tob. Ora Dio dice lo tob. La creazione dell’essere umano non è ancora completa, come si diceva alla fine di ogni giornata quando le cose erano finite.
Non è ancora completa, non è ancora buona e bella in quel senso, gli manca qualcosa. Gli manca l’aiuto che vuol dire alleato, alleato fedele, quello che viene in tuo soccorso quando tu sei in pericolo, quello che ti aiuta quando sei in difficoltà, quello che condivide con te tutto perché fa alleanza con te e ormai quindi due sono diventati uno. Un aiuto che gli sia corrispondente.
Non c’è ancora e quindi la persona umana non è ancora tob. E quando diventa tob? Quando questa persona diventa ’ish e ’ishsha, uomo e donna. L’idea che di solito si dà di questo testo è che c’è la prima parte del racconto che racconta la creazione dell’uomo e la seconda parte che racconta la creazione della donna. Questa divisione non rende assolutamente ragione, non solo del modo in cui si utilizza il termine l’Adam, notate che lo usano con l’articolo, non è Adamo.
Ma soprattutto non rende conto di ciò che il racconto dice. Perché se fosse così, solo l’uomo è fatto di polvere, la donna no! Solo l’uomo riceve il comando e quindi non è Dio, la donna no! Quindi è Dio. Capite che non può funzionare. E’ chiaro che chi è fatto dalla polvere e chi riceve il comando “Tu sei un essere umano e non puoi essere Dio” è l’essere umano, non solo il maschio. Quello che il nostro racconto ci vuole dire è che questo essere umano non è completo, finché non entra nella dimensione dell’alterità e finché non scopre di essere maschio e femmina e quindi diverso e quindi in relazione costitutiva e quindi in perenne stato di bisogno.
Perché nessuno di noi è mai persona umana completa. Noi siamo esseri di bisogno. Siamo esseri costitutivamente bisognosi dell’altro e soprattutto di quell’Altro che è Dio. Il racconto non è allora: prima viene creato l’uomo e poi la donna. Tanto è vero che quando viene creata la donna, Dio non fa un altro atto di creazione, non prende altra polvere, come invece fa per gli animali. C’è un unico racconto in cui c’è la descrizione della creazione dell’essere umano che è essere umano, fatto dalla terra, che riceve il comando, che dà il nome agli animali e che definitivamente è ’ish e ’ishsha, uomo e donna, quindi alterità con tutto quello che questo significa.
E la dimensione dell’essere mancante è perché ad uno viene tolto il fianco (non c’entra niente la costola, il termine ebraico vuol dire lato, fianco, si usa addirittura per indicare il lato di un edificio) e questo ora è senza un fianco e quest’altra pure. Si trasforma in racconto quello che Gen 1 dice sotto forma di proverbio. Gen 1,27 dice: “Dio creò l’uomo (Adam) a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò”. C’è il cambio di pronome, “a sua immagine lo creò” (la persona umana, la prima parte di Gen 2), “maschio e femmina li creò” (la seconda parte di Gen 2). Questa persona umana che è diventata due, scopre di essere due nominando l’altra e se stessa.
La persona umana dice: “Questa è parte di me (riconoscendo lei prendo coscienza di me), si chiamerà ’ishsha perché viene da ’ish (ed è solo perché dico che lei si chiama ’ishsha che io scopro che mi chiamo ’ish). Il nome che ’ish dà ad ’ishsha non è come il nome che Adam dà agli animali, che è segno di potere. Qui il gioco tra ’ish ed ’ishsha (vengono da radici diverse ma dal suono sembrano la stessa parola) è che ’ishsha viene detto per primo. Quindi è ’ish che dà il nome ad ’ishsha, ma non facendo un atto di supremazia come con gli animali, ma riconoscendo la realtà di ’ishsha e pronunciando allora il nome dell’altra che è ciò che permette adesso a lui di pronunciare il suo nome. ’Ish non poteva dire di chiamarsi ’ish se non avesse detto che l’altra era ’ishsha.
E’ una situazione di assoluta reciprocità in cui l’uno si riconosce nell’altro e prende coscienza di sé prendendo coscienza dell’altro. Adesso Adam è tob, è completo. Questo è il progetto sull’uomo, questo è, come lo chiamo io, il sogno di Dio sull’uomo. Un uomo che vive nell’assoluta reciprocità, che vive nella libertà dell’obbedienza, che gestisce la vita come dono di Dio, che non si sostituisce a Dio, un uomo che può raggiungere la felicità proprio in questo, un uomo che rispetta l’altro e sa di aver bisogno dell’altro, che sa di essere costitutivamente relazione e insieme bisogno. Questo è il sogno che Dio ha sull’uomo.
Solo che la realtà, il modo con cui di solito si sperimenta la realtà umana e quindi anche il modo con cui gli autori di questi testi sperimentavano l’uomo sembrano contraddire questo sogno di Dio. Dio ha fatto le cose tutte buone, anzi molto buone. L’uomo che esce dalle mani di Dio dunque è buono. Allora perché fa cose cattive? Questa è la domanda. Ed è la domanda a cui Gen 3 cerca di rispondere ancora una volta non in una prospettiva semplicemente temporale, cronologica, come se dicesse solo: “Prima l’uomo era buono, poi ha peccato ed è diventato cattivo”. Questa prospettiva non sopporterebbe due racconti di creazione diversi. Non è esattamente questo, quanto un modo con cui Gen 3 riflette su quella che è la realtà umana e la realtà umana di peccato, di rifiuto del progetto di Dio, presentandolo come qualche cosa che avviene ai tempi delle origini. Senza voler fare nessuna ricostruzione cronachistica.
Ma per dire innanzitutto che questa è in qualche modo la realtà più profonda del peccato dell’uomo. Gen 3 dice: Dio è buono, l’uomo è buono, ma può rifiutarsi al progetto di Dio. Attraverso questo racconto indica quali sono le coordinate per capire di che rifiuto si tratta. Per capire cosa vuol dire che l’uomo rifiuta il progetto di Dio, i segni, ciò che avviene. Non solo ciò che è avvenuto in principio, ma cos’è che avviene ancora e che continuamente avviene ogni volta che l’uomo pecca. Questa è la prospettiva. Quindi una risposta al problema del male che lascia il problema del male alla sua dimensione misteriosa e inspiegabile, almeno ad un certo livello, per però spiegare e identificare quali sono i meccanismi del peccato umano e quindi quali sono i meccanismi del rifiuto da parte dell’uomo della bontà che invece Dio dona e che Dio è. e dopo si fanno tutte le cose che servono per l’uomo. Vedete che è la stessa cosa.
Genesi 3
In Gen 3 il problema è il rifiuto dell’uomo e l’uomo diventa improvvisamente il protagonista del racconto. Fino ad ora, in Gen 1 e Gen 2 il protagonista del racconto era Dio, era Lui che faceva. C’era sì l’uomo, ma era Dio che agiva da protagonista. Ora l’essere umano nella sua realtà completa di uomo e donna, che vive nel giardino che Dio gli ha donato, diventa protagonista. E’ come se il racconto ci dicesse: “Bene, ora ci concentriamo sull’uomo, e su un uomo che è in qualche modo adulto e che ormai interagisce con la realtà che ha intorno, il giardino, che è il mondo. E dove, certamente, Dio c’è, ma non più con quella presenza primaria come era nel racconto finora, perché Dio è intervenuto, ha creato l’uomo, ha creato il giardino, ora il giardino glielo ha affidato ed è come se Dio un po’ si ritirasse dalla scena. Non perché se ne va o si disinteressa, ma perché il giardino c’è, l’uomo anche, ma che adesso l’uomo viva nel giardino.
La scena si concentra sull’uomo che è stato messo nel giardino, lo coltiva, lo custodisce, entra in relazione con le cose che gli stanno intorno e ad un certo punto entra in relazione con uno degli animali che stanno nel giardino, il serpente. Compare dunque questo nuovo personaggio, che però fa parte delle creature, delle bestie terrestri che Dio ha creato, quindi niente di trascendente o di trascendentale. E’ uno degli abitanti del giardino, con cui bisogna che l’uomo entri in relazione e con la cui realtà l’uomo possa interagire sapendola manovrare. E’ una realtà un po’ problematica, dice il testo, perché si tratta sì di une delle bestie selvatiche fatte da Dio, ma della più astuta di tutte le bestie selvatiche. C’è un elemento di astuzia che viene sottolineato e che comunque già permette al lettore di pensare che qualche cosa dovrà succedere, perché se questo è astuto probabilmente il confronto tra l’astuzia del serpente e l’uomo che abita nel giardino sarà un confronto con cui bisognerà misurarsi. Notate, non viene detto esplicitamente che questa astuzia è malvagia, e non può essere detto, perché questa è una bestia creata dal Signore e le cose create dal Signore sono tutte buone. Solo che l’astuzia, come tutte le altre cose, dipende da come viene usata. E dipende anche da come l’uomo si pone davanti alle parole astute del serpente.
Parole astute del serpente che cominciano mettendo in dubbio la ragionevolezza del comando di Dio e quindi mettendo in dubbio la bontà stessa di Dio. Nella vostra traduzione si dice:
Egli disse alla donna: “È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?”
In ebraico invece, di per sé, il segno che indica che siamo davanti ad una proposizione interrogativa non c’è. L’ebraico ha i modi per dire che la frase che comincia è una interrogativa e questi modi qui mancano. Dunque a voler proprio essere pignoli, quello che il serpente inizia a dire alla donna, non è una domanda, è una constatazione. Si potrebbe tradurre così: “E disse alla donna: Beh, ecco, allora Dio ha detto...”. Vedete, questo è significativo. Perché se uno arriva qui e ci dice: “Sentite un po’, è vero che Bruna ha detto?” Voi prima di rispondere ci pensate un attimo, perché è evidente che vi stanno mettendo in mezzo. Vi stanno chiedendo di confermare certe cose e, con una certa solennità, di prendere posizione per dire se davvero io ho detto qualcosa oppure no. E quindi voi prima di rispondere ci pensare un attimo.
Ma se uno arriva qui e comincia a dire: “Dunque, Bruna questa mattina diceva questo...”, voi senza mettervi sulla difensiva, come davanti ad una domanda, potete assentire. Quello che il racconto vuole dire non mettendo il punto interrogativo è che quindi la tentazione su Dio ed il peccato - perché di questo si tratta - comincia in modo apparentemente innocuo, in modi davanti a cui la persona non si mette sulla difensiva perché non ne riconosce immediatamente l’insidia, perché il serpente, in questo senso, è astuto. Eccola allora l’astuzia, questa capacità - che qui viene applicata al serpente, ma il serpente è la tentazione - di insinuarsi nelle pieghe della coscienza umana di soppiatto, senza farsi accorgere, senza farsi scoprire come tentazione, ma entrando apparentemente in un dialogo tranquillo in cui si parla e basta, come se le cose non avessero delle conseguenze.
Ecco che allora noi capiamo meglio perché viene messo in gioco il serpente e non un altro animale. Voi sapete che poi la stessa Bibbia rilegge questa vicenda e rilegge la figura del serpente come la figura del Dragone, del Serpente, con le maiuscole. Ma questo non ci deve far dimenticare la connotazione immediata del racconto, la scelta di un serpente che, in fondo, è solo un animale, un serpente con la esse minuscola, anzi, visti i serpenti che si trovano in terra di Israele è un serpentello fondamentalmente. Però portatore di questa insidia che lo rende particolarmente pericoloso anche se in modo diverso da un altro animale che può fare più paura e che è ancora più pericoloso come un leone. Il leone ha delle capacità aggressive incredibili, certamente maggiori di quelle del serpente, che fondamentalmente non attacca, tende a scappare. Il leone ti divora, il serpente può morderti, ma puoi evitarlo più facilmente, il leone è molto veloce e forte. Il serpente non è veloce, è veloce nello scatto, ma un uomo corre più veloce di un serpente. Il serpente non ha forza, visto che si tratta di serpentelli. Non dobbiamo immaginare i serpenti brasiliani, gli anaconda, ma serpenti piccoli. Solo che del leone tu ti accorgi e del serpente no.
Ecco l’insidia, ed ecco perché qui non è un leone o un lupo che parla con la donna nel giardino, perché il serpente è quello che descrive Amos in modo grandioso, in Am 5,18. Si sta parlando del giorno del Signore, qualcosa di terribile, davanti a cui si è completamente indifesi. Amos per far capire questo dice:
E’ come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso, entra in casa, appoggia la mano sul muro e il serpente lo morde.
La scena è questa: stai camminando e incontri un leone, ti metti a scappare inseguito dal leone in preda al terrore. E quando sei riuscito a metterti in salvo dal leone ecco che trovi un orso! Diciamo che si tratta di una persona sfortunata! I nostri ragazzi direbbero in altro modo... Sei riuscito a scappare dal leone e ti trovi davanti ad un orso. Cerchi di salvarti e corri per entrare in casa. Ti sei messo in salvo dal leone, ti sei messo in salvo dall’orso, arrivi finalmente a casa. Chiudi la porta e dici: “E’ fatta! Mi appoggio un attimo perché non ne posso più”. E il serpente ti prende. Perché quando vedi il leone e l’orso ti difendi, fuggi, quando sei davanti ad un serpente sei nell’impossibilità di metterti sulla difensiva perché il serpente non lo vedi, perché sta dove non te lo aspetti e perché ti morde proprio quando tu, credendoti al sicuro, hai abbassato ogni difesa. Ecco il concetto di serpente ed ecco il concetto di insidia, di astuzia.
Senza volere fare dello psicologismo, questo capitolo 3 va letto fin dal primo versetto come un testo che va alla ricerca di alcune coordinate di riferimento per capire come funziona la tentazione, cioè come comincia, come ti ingabbia, che tipo di reazione provoca in te. Fin dall’inizio il testo ci dice che quando siamo davanti alla tentazione siamo davanti a qualcosa che non riusciamo a riconoscere come immediatamente pericoloso. Perché è come il serpente che ti morde quando non te lo aspetti e si presenta come il serpentello innocuo che non ti fa neppure le domanda che ti metterebbe sulla difensiva, ma si mette a chiacchierare con te del più e del meno per portarti dove vuole andare lui. Allora davanti a questo inizio di chiacchierata del serpente, la donna entra in dialogo.
Dicevamo che la formulazione del serpente butta là con noncuranza una menzogna totale su Dio. Dice: “Beh, ecco Dio ha detto: Non mangerete di nessun albero del giardino”. Detto così è lo stravolgimento totale di quello che ha detto Dio, il quale invece ha detto esattamente il contrario: "Di tutti gli alberi del giardino potete mangiare, ma non di quello della conoscenza del bene e del male”. Tradotto in italiano diventa evidente che il serpente sta mentendo. In ebraico è diverso. E’ difficile renderlo in modo efficace. “Tutto”, “tutti”, “ogni”, questi aggettivi in ebraico si dicono con una parola che è kol. Quando io dico “kol libro” posso intendere “tutto il libro” oppure “ogni libro”, a seconda se metto l’articolo o no. Ma ci sono dei casi in cui l’articolo potrebbe esserci o meno. Allora questa parola ebraica kol, a seconda se poi l’oggetto a cui si riferisce ha o no l’articolo, può significare tutto il libro o ogni libro. Proprio come in italiano, l’articolo fa la differenza. Ma siccome in italiano l’articolo si può mettere sempre, ma in ebraico ci sono dei casi in cui anche se ci potrebbe essere l’articolo tu puoi non metterlo, ecco che tu hai questo kol che non sai se vuol dire tutto, o tutti, o ognuno.
Quando Dio dà il suo comando all’uomo dice: “di ogni albero del giardino”. Però potrei tradurre anche “di tutti gli alberi del giardino”. Quindi Dio sta dicendo: “di ogni albero potete mangiare” oppure “di tutti gli alberi del giardino potete mangiare”. In un caso o nell’altro il significato non cambia.
Se però io faccio come il serpente e davanti a questa frase metto un “non”, allora le cose cambiano completamente. Perché la frase diventa: "Non mangerete di ogni albero del giardino", e questo potrebbe voler dire che potete mangiarne tanti, ma non di ogni albero. Può essere: "Non mangerete di tutti gli alberi del giardino", nel senso che ne mangiate di quasi tutti. Ma se c’è quel “non” davanti può anche essere: "Non mangerete di nessun albero del giardino". Perché il kol che vuol dire “tutto” viene negato dal “non” e “non tutto”, per noi, diventa “nessuno”.
Facciamo una sintesi. Quando Dio dice: voi potete mangiare di ogni albero o di tutti gli alberi, la frase ha un solo senso: “Potete mangiare quello che vi pare”. Quando invece questa frase viene negata, quando l’atto del mangiare viene negato, il senso non è più univoco, diventa equivoco. Perché può essere che io neghi il fatto che voi potete mangiare di tutti gli alberi tranne alcuni, ma può anche essere che la frase significhi che non potete mangiarne nessuno. La frase del serpente allora non è una domanda, quindi uno la prende alla leggera. E’ formulata dicendo il contrario di quello che ha detto Dio, però lo dice ridicendo quello che ha detto Dio solo aggiungendo un piccolo non. E questo piccolo non fa sì che la frase che il serpente dice sia equivoca. Per cui tu puoi capire che lui sta negando totalmente quello che ha detto Dio, ma puoi anche capire che lui sta dicendo che in fondo no, "potete mangiare quasi di tutto, non di tutto" e che quindi ancora una volta ci si possa mantenere ad un livello di innocuità.
Cerco di far vedere come il testo gioca su delle piccolezze perché colui che legge capisca che il serpente è astuto. Quando la donna, davanti a questo discorso del serpente, che sembra variare solo di poco il discorso di Dio, che oltretutto non è neanche chiaro, che non impegna con una risposta precisa, reagisce dicendo:
E disse la donna al serpente:
“Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: Non ne mangerete e non lo toccherete altrimenti morirete”.
La donna risponde – sembra - ristabilendo la verità. Solo che tu ti accorgi solo quando è troppo tardi che il serpente ti ha morso. Qui si vede che l’astuzia del serpente ha cominciato a fare effetto. Il che, tradotto in termini spirituali, vorrebbe dire che quando sei alle prese con la tentazione, tu non te ne accorgi; poi, quando anche cominci ad accorgertene, fai in modo di autoconvincerti che, in fondo, a parlare con il serpente non c’è proprio niente di male e che non sta dicendo neanche cose tanto sbagliate. Quindi tu puoi andare nella linea del serpente ed illuderti di star resistendo a certe prospettive sbagliate e invece senza accorgertene piano piano finisci col dire proprio quello che il serpente voleva farti dire. Perché la donna risponde apparentemente bene, probabilmente autoilludendosi di rispondere bene, ma invece è ormai pienamente nella linea del serpente.
Per tre motivi fondamentali. Innanzitutto - ci avete fatto caso? - sparisce il termine tutti o ogniLei dice solo: “Del frutto degli alberi del giardino noi possiamo mangiare”. E già quindi c’è un tutti di meno. Come se la donna cominciasse a non vedere più l’assoluta gratuità, magnanimità di Dio - tutti gli alberi, tutto è vostro! - ora non sono più tutti gli alberi, ma solo il frutto degli alberi. Tra l’altro “alberi” è detto al singolare perché si usa un collettivo per cui sembra ancora di meno: “il frutto dell’albero”.
Poi dice che dell’albero proibito Dio ha detto: “Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare”. E Dio non ha detto di non toccarlo. E perché è grave invece che lo dica la donna? Perché la donna dicendolo, senza volerlo, sta confessando di non capire più il senso del comando di Dio. Vi ricordate perché? Il senso del comando di Dio era: tu non puoi mangiare di quell’albero lì perché quello è per conoscere tutto, è proprio solo di Dio. E quindi tu non lo puoi mangiare. E questo è ragionevole. Anzi è bello che Dio me lo dica, perché mi indica il cammino della mia verità. Ma se io non capisco più questo, mi trovo davanti ad un comando di Dio di cui io non capisco più il motivo o il senso, e davanti a cui quindi io non riesco più a percepire il fatto che quel comando è un comando buono e che Dio me lo dà perché mi vuole bene. Se mi trovo davanti ad un comando di cui non capisco il senso, posso solo avere la percezione che mi hanno detto di fare una cosa e a me tocca di farla. Ma non so perché, non so il motivo che c’è sotto e quindi non so neppure se mi dicono di farla tanto per farla, se mi dicono di farla perché mi vogliono male, o se mi vogliono bene. Ma non lo so!
Se mi dite di non mangiare una cosa e io non so perché voi mi dite di non mangiare quella cosa, non so se mi volete bene o invece mi odiate e me lo dite per farmi del male, per farmi cadere, per tendermi una trappola o per prendermi in giro. Io non lo so. Tutto dipende dal capire il senso dei comandi. Per inciso guardate che questa è l’obbedienza che la Bibbia chiede all’uomo. La Bibbia dice che l’obbedienza che Dio vuole dall’uomo è un’obbedienza che, avendo capito qual è il senso del comando, obbedisce al senso di quel comando.
Lo fa volontariamente, spontaneamente, in un’obbedienza che diventa assolutamente libera. Perché io, siccome capisco qual è il senso del comando e capisco che è un comando giusto, faccio quello che mi si chiede perché anch’io sono convinta di farlo e voglio farlo. Dio non sa che farsene dell’obbedienza formale di chi fa quello che Lui gli dice senza sapere perché. L’obbedienza che la Bibbia chiede è un’obbedienza particolarmente impegnativa perché bisogna capire cosa ci viene chiesto. E capire cosa ci viene chiesto non solo ci impegna, ma impegna l’intelligenza e anche proprio il cuore perché viene messa di mezzo la nostra volontà. Ma poi ci impegna sul piano decisionale perché obbedire veramente a certi comandi può persino paradossalmente portarci a fare concretamente delle cose diverse da quelle che apparentemente ci vengono chieste.
Ho un esempio molto bello. S.Teresa d’Avila, lasciando delle prescrizioni per il comportamento delle sue suore, ad un certo punto ha lasciato detto che, quando si fonda un nuovo Carmelo, bisogna costruirlo in modo che l’infermeria venga messa a nord. Allora noi possiamo obbedire a questo in due modi. Possiamo dire: c’è scritto così e noi lo facciamo così. Tutto a nord! A noi interessa obbedire. Lei ha detto di mettere l’infermeria a nord e noi così facciamo. Precisi, che sia rigorosamente a nord, non magari a nord-est! Siamo nel 1815, andiamo a fondare un convento carmelitano a Oslo, in Norvegia, e dopo pochissimo tempo non avremo più suore malate. Perché dopo poche ore in infermeria prenderanno la polmonite e moriranno! Poi però scopro che S.Teresa d’Avila dice queste cose parlando di una città in Spagna, dove fa molto caldo. E allora capisco che il senso del comando era un altro. Le carmelitane seguono delle regole molto dure, ma nel caso in cui le suore sono malate ci sono altre esigenze. Allora non vale più l’ascesi, la via della durezza, il sacrificio, la passione. Niente, qui prevale l’amore, qui prevale la carità. Se la vostra sorella è malata voi la dovete mettere nel posto in cui soffre di meno, in cui c’è più fresco, e quindi la dovete mettere a nord.
Quindi se uno capisce questo quando poi vuole obbedire a S.Teresa e va a costruire il Carmelo a Oslo, mette l’infermeria a sud, per obbedire a S.Teresa che gli ha detto di metterla a nord. Ora questa è l’obbedienza biblica. E guardate che comunque niente è automatico, perché il rischio è che qualcuno dica: va bene, abbiamo capito, d’ora in poi facciamo il contrario di quello che ci dicono... No! Ogni volta uno si deve interrogare sul senso e poi obbedire al senso. Fate attenzione: al senso attraverso la lettera. Guai a lasciare la lettera. Che uno non dica: beh, io ormai obbedisco al senso, ormai ho lo Spirito, ormai della lettera della Legge non mi importa niente. Non ha più niente a che vedere con me. Non è così, perché se S.Teresa non avesse lasciato scritta questa cosa dell’infermeria, non avrebbe lasciato questo insegnamento dell’amore per la sorella malata. La lettera è fondamentale. Solo che poi la devi capire e devi obbedire. Devi obbedire alla lettera, ma nello Spirito.
Quando noi siamo davanti ad un comando di Dio, noi abbiamo la possibilità o di mettere l’infermeria a nord o di metterla a sud. Di obbedire secondo il senso o di obbedire come si obbedisce ad un despota: ha detto di fare così ed io lo faccio. Se io entro in questo tipo di obbedienza, sono obbediente in modo servile, non da figlio, ma da schiavo. L’obbedienza formale, che si limita a fare, senza cuore. Quando cominciamo ad obbedire così a Dio senza più capire ciò che Dio ci comanda e limitandoci ad osservare la lettera, quello che avviene è che il comando di Dio inevitabilmente comincia ad espandersi, perché invece di essere un comando diventa un tabù. Perché io, donna che sono nel giardino, non so più perché Dio mi ha detto che non devo mangiare di quell’albero, e allora dico: “Boh, mi ha detto di non mangiarlo... non lo mangio. Non lo mangio... ma potrò toccarlo?”. Se io non capisco perché muoio se lo mangio, mi può venire il dubbio che potrei morire pure se lo tocco. Allora per sicurezza non lo tocco nemmeno... Ci potrò passare vicino? Sai, per sicurezza, evitiamo anche di passarci vicino. Lo potrò guardare? Nel dubbio meglio anche non guardare. Allora io vivo nel giardino, che dovrebbe essere il luogo della mia gioia, evitando di toccare tutto, di guardare, con la testa girata indietro.
Uno allora arriva a dire: “Se è così, io dal giardino me ne vado!” E’ facile ridere se diciamo questo, ma pensate a cosa succedeva quando ci si diceva che non si può mangiare la carne al venerdì. Ed era una cosa che aveva un senso bello, perché la Chiesa come madre ci dava delle indicazioni di senso. Ci diceva: guardate il venerdì è il giorno in cui si fa memoria della Passione del Signore, allora è anche il giorno in cui si fa memoria del fatto che la rinuncia, anche la sofferenza, se vissute in un certo modo, hanno un senso. E poi c’è un’esigenza di carità, di condivisione. Allora il venerdì non mangiate carne, che è un cibo da ricchi. Fatelo come fatto simbolico. E’ un modo con cui voi assumete quello che ha il sapore di una rinuncia, il giorno in cui il Signore Gesù ha rinunciato a difendersi per salvare gli altri e quindi ad entrare nel cammino della morte e questo diventa poi la possibilità di condividere con altri, perché quello che tu non utilizzi oggi per comprare la carne può servire ad altri per mangiare. Vedete che era molto bello.
Ma voi vi ricordate che noi avevamo il problema di capire se il venerdì si poteva mangiare il brodo fatto con il dado perché non sia mai nel dado c’era l’estratto di carne? E non è come la donna che dice: “Oddio, forse non lo posso guardare?” Poi magari c’era chi poteva che non mangiava nemmeno il brodo di carne per essere sicuro, però una bella sogliola, frutti di mare e, ogni tanto, un’aragosta se la mangiava. E aveva fatto il venerdì. E’ quello che sta succedendo alla donna, che quindi dice: “Non lo si deve neanche toccare”. Che non è vero, è lei non ha capito niente.
Terzo errore della donna, e questo è quello definitivo. La donna dice: “Dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non lo dovete mangiare e non dovete toccarlo”. Ma vi ricordate che gli alberi sono due e che l’albero che sta in mezzo al giardino è l’albero della vita? E qui la donna è caduta definitivamente nella trappola perché parla dell’albero della vita come se invece fosse l’albero proibito. Questa confusione degli alberi dice che tutto si è confuso nella coscienza della donna e che ormai la donna percepisce l’obbedienza al comando di Dio come qualche cosa che non le permette di vivere e di vivere in pienezza. Prima io vi facevo ridere però alla fine uno dice: “Se è così che devo vivere dentro al giardino, io così non vivo più”. Ma quante volte noi davanti a certe esigenze evangeliche, quante volte davanti a quello che ci sembrava essere su di noi la volontà di Dio, noi abbiamo detto e diciamo: “Se è così io non vivo più?” Credo che nella vostra vita prima o poi sia successo.
Questo è il meccanismo della tentazione, questo è il meccanismo del peccato secondo Gen 3. Per cui la donna si ritrova in realtà senza quasi accorgersene in pieno discorso del serpente, quasi senza saperlo. Ma, alla fine, sapendolo invece perfettamente. Il cammino è lungo per arrivare a questo, ma si ritrova a dire insieme al serpente che Dio è cattivo perché ha dato un comando cattivo. Perché ci dice di fare delle cose non perché ci vuole bene e vuole la nostra felicità; ci dice di fare delle cose o di non farle perché invece non ci ama. E questo che Lui ci dice ci mette in condizione insostenibile di sofferenza, di non vivere più in pienezza. Se Dio è questo io non riesco a riconoscere in Lui un Padre.
Infatti appena la donna ha dato questa risposta il serpente scopre definitivamente le carte. A questo punto non ha più motivo di tenerle nascoste, e dice: “No, voi non morirete affatto e anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio conoscendo il bene e il male”. Che tradotto vuol dire: “Hai proprio detto bene, Dio è cattivo. E il comando che ti ha dato non è per il tuo bene, ma per il suo proprio interesse. Davanti a un Dio così, cattivo, dispotico, che mi vuole morto, allora è meglio che muoia Lui”.
Allora la donna decide di prendere il frutto. Perché a questo punto cambia anche il suo modo di vedere l’albero. Lo guarda, dice il testo, e vede che “il frutto è bello, è buono da mangiare, è desiderabile”. E’ cambiato il cuore e quindi cambiano anche gli occhi. Nel momento in cui io dico che Dio è cattivo e mi chiede cose che non sono per il mio bene, allora le cose proibite diventano belle e desiderabili, io non le so più riconoscere per quello che davvero sono. Io non so più capire che quello mi fa male, e invece dico: “Invece mi farebbe proprio un gran bene”. Che è il modo tranquillo con cui noi solitamente iniziamo a peccare quando davanti a qualcosa che sappiamo essere male, cominciamo a dirci: “Dunque, Dio ha detto che questo è male. Io ero convinta di questo fino ad un po’ di tempo fa.. Però adesso le cose sono cambiate. Può anche darsi che effettivamente questo sia male, però è male in genere, ma non per me. In questa situazione particolare non è male, anzi, tutto considerato, è bene, mi aiuta farlo. E perché mai non dovrei farlo? Che male c’è?” E lo fai.
Perché se noi fossimo davvero convinti che quello è male noi non lo faremmo. Perché nessuno di noi è talmente folle da fare qualche cosa che lo distrugge. Se noi fossimo consapevoli che il male ci ammazza - perché così è - noi non lo faremmo. Ma l’idea di Gen 3 è che noi, pur sapendo che il male ci ammazza, ci autoconvinciamo - ecco il serpente, l’inganno, l’astuzia - che invece, in questa particolare occasione a me non solo questa cosa non mi ammazza, ma anzi mi farebbe proprio un gran bene. E lo faccio. Il frutto diventa bello, e se gli occhi decidono che il frutto è bello allora il gesto della mano che prende il frutto è assolutamente automatico. Nel momento in cui tu hai giudicato che ciò che è male invece è bene, il peccato tu l’hai già consumato. E la donna prende il frutto e poi lo dà anche all’uomo.
Dicevamo che davanti alla donna che ormai è rimasta presa in trappola, il serpente dà la sua botta finale per la caduta della donna. Vedete: anche la risposta del serpente è un’affermazione non verificabile. Dice: “No, non è vero, Dio vi ha detto questo perché non vuole che conosciate il bene e il male”, ma una cosa di questo tipo non si può verificare. O ti fidi o non ti fidi. E questo anche è un elemento significativo nell’insegnamento di questo racconto, perché ci dice che noi siamo davanti a due parole, a due sapienze, quella di Dio e quella del serpente. E tu devi decidere di quale ti fidi.
Perché non è verificabile la risposta del serpente come però a volte non è verificabile neppure il comando di Dio. Allora tu puoi fare riferimento alla tua esperienza, all’esperienza di coloro che ti hanno preceduto, ma anche lì dipende se ti fidi o non ti fidi. In altre parole quello che è in gioco è la fede. Ed è inutile andare in cerca di quello che mi può garantire dentro la fede. E’ la fede che si garantisce da sé. Siamo davanti a due sapienze, quella del serpente e quella di Dio.
“La donna ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei”. Vedete, il gesto di per sé è un gesto bello, un gesto di comunione. La donna non tiene per sé il frutto, ma lo dà all’altro. Solo che non ci può essere comunione nella separazione da Dio, nella contrapposizione a Dio. Allora, quello che sembra il gesto bello, io che ho preso il frutto che secondo me è un tesoro prezioso e lo condivido con te, se fatto in contrapposizione a Dio, non è condividere un tesoro, ma la morte.
Il testo qui diventa fortemente ironico. Il serpente aveva detto: “Se voi mangiate del frutto i vostri occhi si apriranno e voi conoscerete il Bene e il Male”. La donna prende il frutto, lo dà all’uomo, lo mangiano e il narratore, ironicamente, chiosa: “E allora si aprirono i loro occhi” - proprio come aveva detto il serpente - “e conobbero” - proprio come aveva detto il serpente - “di essere nudi”. Ecco l’ironia, si avvera esattamente quello che ha detto il serpente, si aprono gli occhi e loro conoscono, solo che invece di conoscere il Bene e il Male, conoscono di essere nudi, cioè conoscono di aver bisogno di difendersi.
Perché cos’è la nudità nella prospettiva biblica? Voi ricordate la fine del capitolo 2 di Gen dice: “L’uomo e la donna erano nudi e non ne avevano vergogna”. Sapete tutti che non c’entra niente qui il comune senso del pudore. Avere vergogna non vuol dire avere pudore. Avere vergogna nella Bibbia vuol dire essere smascherati, riconosciuti colpevoli e perciò dover morire. Dunque la vergogna è una cosa seria. E’ oggettivamente ciò che ti porta alla morte e soggettivamente quel senso di sgomento, di terrore e di smarrimento che si accompagna all’esperienza del morire.
Per questo i Salmi ogni tanto dicono: “Signore i nostri nemici siano svergognati, si copra di vergogna il loro volto”. Noi potremmo dire: “Beh, se è solo questo, che devono diventare rossi di vergogna, ci si può anche stare, se è tutto qui il castigo”. No, lì si sta chiedendo: “Falli fuori tutti, che muoiano!”. Il testo di Gen 2 dice che erano nudi e non avevano paura, non avevano quel senso di sgomento che si prova davanti alla morte. Perché essere nudi vuol dire effettivamente esporsi all’altro, essere simbolicamente senza difese e senza più segreti. E vuol dire che sei in balia dell’altro, perché l’altro ti vede come sei, ti conosce per quello che sei e ti può controllare, manovrare, sei nelle sue mani.
L’idea è: “Erano nudi”, cioè esposti l’uno all’altro, in balia l’uno dell’altro, ma non avevano motivo di averne paura, non era per loro un’esperienza di morte. Tra l’altro pensate anche antropologicamente, nella nostra esperienza anche attuale, come è esplicativa questa faccenda della nudità. La nudità può essere capita all’interno di una percezione ed anche di un rapporto con il corpo proprio e altrui che sia ancora un rapporto di rispetto e di comprensione del mistero. Ma basta accendere la televisione e di misteri ce ne sono pochi. Ma quella è una degenerazione del rapporto al corpo. Se noi parliamo, invece, di un rapporto al corpo serio, provate a pensare cosa vuol dire essere nudi, in positivo, quando un uomo e una donna si amano e fanno l’amore. Lo fanno nudi. E questo non perché è più erotico - anche per carità - ma c’è proprio simbolicamente un esporsi e un darsi totalmente all’altro che la nudità esprime e simboleggia. Io sono ormai completamente senza difese, è quel diventare uno che anche la nudità significa. Da lì nasce poi quella complicità, quel conoscersi, quel non avere più paura dell’altro e che l’altro mi conosca. Che è la meraviglia del volersi bene, perché sono questi i momenti grandiosi del volersi bene. Di due persone che possano fidarsi talmente uno dell’altro da giocarsi la vita intera e per sempre e senza segreti. La nudità.
Ma adesso pensate al negativo, e lo sanno bene gli esperti in tortura. Se tu vuoi piegare la coscienza e la forza di resistenza di un uomo, rimani vestito tu, ma metti nudo lui. Proprio perché uno ha questa percezione terribile dell’essere in balia. Ebbene, dice ironicamente il nostro testo, gli occhi di questi si aprono, e conoscono di essere nudi. E allora immediatamente corrono ai ripari. Prendono delle foglie e cominciano a costruire le loro difese, le loro barriere, che si vede poi bene, servono, sono ormai necessarie. Perché quando Dio interviene e comincia a fare le domande, c’è da parte dell’uomo e della donna la fuga al “si salvi chi può”, “muoia lui purché mi salvi io”. Allora: “Cosa hai fatto tu, uomo?” - “Io? Mica io, la donna! Muoia lei purché mi metta in salvo io”. E la donna: “Io? Mica io! Il serpente!”.
C’è questo gioco terribile dove si vede ormai bene che la solidarietà tra l’uomo e la donna, che pure era stata significata dal gesto della donna che gli dava il frutto, è assolutamente finita, perché si è ormai radicalmente alterato il rapporto tra i due, così come si è radicalmente alterato il rapporto con il mondo. Il giardino invece di essere il luogo da coltivare, in cui camminare la sera insieme a Dio, passeggiando, diventa invece il luogo che tu utilizzi per nasconderti e da cui strappi le foglie per costruirti le barriere.
E si sono radicalmente alterati i rapporti con Dio perché Dio interviene e l’uomo e la donna hanno paura e si nascondono. Quindi vedete che ciò che fondamentalmente costituisce l’uomo - il rapporto con Dio, il rapporto con gli altri e il rapporto con il mondo, e quindi la vita - tutto è radicalmente alterato. E questo è ciò che il peccato provoca. Dio allora in questa situazione che è ormai avvenuta, interviene. Prima con le domande e poi con le sanzioni.
Prima le domande. Non per avere una spiegazione, ma perché l’uomo prenda coscienza della follia di quello che ha fatto. Sono domande in forma accusatoria: “Che cosa hai fatto?” E’ la formula tipica dell’accusa nel resto della Bibbia, dove uno non chiede “Cosa hai fatto?” intendendo “Spiegami cosa è successo”, ma “Ti rendi conto di cosa hai fatto?” perché l’altro possa prendere coscienza del proprio peccato. Solo che, appunto, l’uomo e la donna, davanti a queste domande, invece di prendere coscienza del proprio peccato e quindi di confessarlo, accusano gli altri e ultimamente accusano Dio.
Perché la donna è quella “che tu mi hai messo accanto” e il serpente - la donna non lo dice, ma l’ha detto il narratore all’inizio - è una creatura che Dio aveva fatto. Si vede qui proprio fin dove può arrivare la follia del peccato che ti porta all’autogiustificazione che diventa accusa di Dio, di questo Dio invece che ti sta chiedendo perché ti vuole perdonare. E tu invece lo accusi. “E se Dio non mi avesse messo in questa situazione io non avrei peccato. Se Dio non m’avesse dato la donna io non avrei preso il frutto e se Dio non avesse fatto il serpente... La colpa è di Dio, l’ha fatto lui il serpente mica io”.
Un giro perverso perché arriva fino all’accusa di Dio e che però insieme - io credo - paradossalmente dice anche qualcosa di vero. Non di vero su Dio. Non è vero che Dio è colpevole. Ma qualcosa di vero sull’uomo, o meglio sulla percezione che l’uomo ha di se stesso come peccatore. Perché se voi ci pensate bene, l’uomo pecca sapendo cosa fa e volendolo fare, altrimenti non sarebbe un peccato. Però in questo suo volere, in questo suo sapere cosa fa, c’è una dose notevolissima di inganno e di autoinganno. Per cui da una parte è vero che l’uomo sa quello che fa, dall’altra non lo sa veramente fino in fondo, perché se davvero sapesse quanto il male è distruttivo non lo farebbe. E se finisce per farlo è perché si illude che non sia distruttivo, quindi sa di stare facendo il male, ma non lo sa fino in fondo, e liberamente decide di fare il male, ma di una libertà che non è libera fino in fondo.
Quello che voglio dire è che l’uomo peccatore, dopo il peccato, percepisce se stesso come peccatore, sì, come qualcuno che ha fatto una follia, sì, come qualcuno che ha fatto qualcosa di orribile e non doveva farlo, sì, ma in qualche modo anche come qualcuno che è rimasto misteriosamente vittima delle circostanze, dell’autoinganno, dell’illusione, del momento di debolezza, del momento di ira, di qualche cosa che gli sembra superarlo.
Non a caso il nostro racconto di Gen 3 avrebbe potuto anche essere impiantato in altro modo, cioè con la donna che davanti all’albero lo guarda e dice: “Ma sarà proprio vero che se io lo mangio muoio?” La dinamica in fondo sarebbe la stessa, è la donna che decide di fare il male, ma quando poi questo avviene, uno si accorge di ritrovarsi dentro un giro che è ormai più grande di lui, dentro un giro che lo supera e dentro qualche cosa che diventa quasi impossibile controllare. Tu cominci e ti ritrovi che quello che hai cominciato a fare va fuori di controllo.
Un esempio tipico? Pensate a Davide e Betsabea. Lui voleva passare una notte con una donna bella. Probabilmente illudendosi che questo in fondo non avrebbe fatto male a nessuno. Il marito della donna era pure via, quindi non avrebbe fatto male a nessuno, invece avrebbe fatto bene a Davide perché era un modo per prendersi una pausa dal terribile peso di essere re. Per di più c’era la guerra, quindi era in tensione, era preoccupato, quindi voleva solo passare una notte rilassandosi, magari con l’illusione che l’indomani avrebbe potuto gestire meglio le cose del regno perché era più contento e soddisfatto. Allora in fondo che male c’è nel fare una cosa che tutto considerato mi fa bene? Vedete l’inganno? E quando poi Davide lo fa, ecco cosa succede a lui che voleva solo passare una notte con una donna bella. Si ritrova in una situazione per cui la donna rimane incinta e allora lui fa un obbrobrio inaccettabile, cerca di rifilare il figlio al marito della donna. Chiamando Uria dal campo di battaglia e dicendogli: “Vai a lavarti i piedi”, tradotto: “Vai a letto con tua moglie”, cosicché il figlio risultasse figlio di Uria. E quando Uria non va invece a casa dalla moglie, allora Davide lo uccide - tra l’altro in modo infame, perché è Uria stesso a portare l’ordine di uccisione a Ioab. Tutto è cominciato con la voglia di passare una notte in compagnia di una donna bella.
Tutto comincia così, ma si finisce con un omicidio. Perché quando tu innesti la spirale del peccato, quella ti va fuori di controllo. Allora o tu riesci ad interrompere la spirale confessando la tua colpa, oppure sei costretto a fare altro male per coprire il male che hai già fatto. Si comincia con un adulterio e si finisce con un omicidio. Questo è automatico. Ecco un altro aspetto del perché il serpente è qualche cosa che è al di fuori di me. Ed ecco perché allora c’è anche un pochino questa percezione che l’uomo ha sì delle propria responsabilità, ma contemporaneamente sa di essere stato vittima. Di nuovo siamo nel paradosso, perché se sei libero e fai il male volontariamente non è vero che sei vittima. Invece sono vere tutte e due le cose. Vittima delle circostanze. Bastava che Davide passeggiasse sulla terrazza mezz’ora prima o mezz’ora dopo e non avrebbe visto Betsabea e non sarebbe successo niente. Vittima delle circostanze. Vittima di una pulsione sessuale che non è stato capace di controllare, vittima del desiderio. C’è qualcosa di questa percezione che l’uomo ha del peccato. Siamo responsabili, ma vittime di inganno, però responsabili di quell’inganno. E’ così.
Quando questi dicono “Non è stata colpa mia” mentono, e entrano nella spirale folle del male e contemporaneamente dicono qualche cosa però invece della loro percezione. Che è però appunto una percezione di inganno e una confessione di debolezza. Dio interviene con le sanzioni. Dio interviene sulla realtà di questi che ha interrogato e dice al serpente:
“Poiché tu hai fatto questo,
sii tu maledetto più di tutto il bestiame
e più di tutte le bestie selvatiche;
sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno”.
Poi dice alla donna:
“Moltiplicherò
i tuoi dolori e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ma egli ti dominerà”.
Poi dice all’uomo:
“Maledetto sia il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l’erba campestre.
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;
finché tornerai alla terra,
perchè da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere tornerai!”.
Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Qui Dio sanziona il male che è avvenuto. Però - se voi guardate bene - qui Dio sta semplicemente dicendo quello che è già avvenuto. Perché ormai già si sono alterate le relazioni tra l’uomo e la donna. "Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà." Ma questo è già successo. E già si sono alterate le relazioni con il mondo, “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane”. Già l’armonia con la terra non c’è più e quindi è già successo. E già si è alterato il rapporto con la vita: “Con dolore partorirai”. Ma questo è già successo.
Quello che voglio dire è che Dio, dicendo queste cose, non sta inventandosi delle punizioni da aggiungere al male che l’uomo ha fatto per punire il male. Sta semplicemente dicendo quali sono le conseguenze di questo male che è già stato fatto e quali sono queste conseguenze che già si sono verificate. E non c’è bisogno che Dio punisca, perché è già il male che punisce l’uomo. Perché la vera punizione del male sono le conseguenze del male e non serve che Dio se le inventi. Se la mamma dice al bambino: “Non mangiare tutta la cioccolata perché sennò poi ti viene il mal di pancia” e il bambino ruba la cioccolata e la mangia, poi non serve che la mamma gli dia pure uno schiaffone, ma bisogna che la mamma intervenga per far capire al bambino che si sta punendo da solo. O meglio che ciò che lo punisce è il male che ha fatto, perché la punizione non è lo schiaffo, ma il mal di pancia. E se, per un caso fortunato, il mal di pancia al bambino non viene, la punizione c’è lo stesso, ed è che si sono incrinati i rapporti con la mamma. Ed è questo che fa male, non il fatto che tua madre ti dia uno schiaffone.
Allora, questi discorsi di Dio non sono lo schiaffone della mamma, ma il modo in cui Dio dice: “Ecco, questo è quello che è successo”. Solo che nel momento in cui Dio lo dice, persino quello che è successo, persino queste terribili conseguenze del male che sono la punizione del male, persino queste cambiano di segno e diventano positive. Perché Dio condanna il serpente e dice che proprio quell’uomo che è vittima del serpente, proprio lui lo schiaccia. E che proprio quel tallone che è la parte più indifesa dell’uomo nei confronti del serpente - perché lì il serpente può mordere senza che tu te ne accorga, perché tu le punte dei piedi le vedi, ma il tallone non riesci a vederlo - proprio quello che è il luogo della tua debolezza e che tu non puoi difendere, proprio quello diventa ciò che invece vince il serpente.
Questo annuncio di vittoria cambia di segno pure le sanzioni sull’uomo e sulla donna. Perché quando Dio dice alla donna “Con dolore tu partorirai”, da una parte sta dicendo che si sono alterate le relazioni con la vita, e questa è la conseguenza del male, ma dall’altra parte, intervenendo su questa realtà Dio la sta trasformando, perché questo dolore - che è la conseguenza del male ed è quindi la punizione che il peccato stesso infligge all’uomo - questo dolore misteriosamente diventa invece salvifico per la donna, perché se il peccato è voler diventare come Dio, ebbene il momento in cui la donna è più simile a Dio è quando genera una vita.
E se adesso quella generazione della vita è segnata dal dolore, proprio quel dolore aiuterà la donna a non illudersi più di poter essere Dio. E allora proprio quel dolore sarà ciò che salverà la donna. Così come il sudore della fronte quando l’uomo lavora, perché è lavorando che l’uomo è più simile a Dio - per il discorso che facevamo nell’incontro precedente, perché è lavorando che l’uomo crea. Ma se ora crea con il sudore della fronte, non può più illudersi di essere Dio. E se quest’uomo ancora si illude - e si illude - perché dice Dio alla donna “Verso di lui è il tuo istinto”, il tuo desiderio, il tuo bisogno di lui, quindi una confessione di debolezza da parte della donna. “Verso di lui è il tuo bisogno e tu sei debole e lui invece, il forte, invece di chinarsi sulla debolezza per aiutarla, lui userà la sua forza per schiacciare la debolezza", la perversione, allora, la debolezza della donna la salva, perché se è debole vuol dire che ha bisogno di aiuto, che quindi non è Dio, che quindi ha bisogno di Dio.
Se l’uomo ancora si illude di non aver bisogno di Dio e di essere forte, ci sarà allora la morte, ci sarà quel tornare alla terra che lo metterà davanti alla sua verità di debolezza e davanti alla morte non c’è più nessuna possibilità di illudersi di essere ancora Dio. Paradossalmente allora proprio la morte che è la conseguenza maledetta del peccato, proprio la morte che è entrata a motivo del peccato nella realtà dell’uomo come viene detto e nel Libro della Sapienza, e nelle Lettere di Paolo, proprio la morte può diventare invece l’occasione definitiva per lasciarsi salvare da Dio. Perché proprio nella morte l’uomo può finalmente - e direi inevitabilmente - scoprire di non essere Dio e di avere bisogno di essere salvato.
Ed è allora proprio la morte, la maledetta conseguenza del peccato, che diventa l’ultima, meravigliosa, benedetta offerta di salvezza per l’uomo. Vedete che quelle che sono le sanzioni, sanzioni non sono. Nel senso che sono sanzioni nella misura in cui dicono le conseguenze del peccato che già ci sono e, dette da Dio, assunte in qualche modo da Dio, cambiano di segno e da negative che sono diventano positive. E’ chiaro che tutto questo va capito in senso simbolico. Non è che adesso speriamo che la donna soffra tanto quando partorisce e dovesse soffrire un po’ meno del previsto, facciamo qualche cosa per farla soffrire di più! Non è questo. Si sta parlando a livello simbolico, prendendo i due luoghi tipici della somiglianza con Dio dell’uomo e della donna, il cambiare il mondo da una parte, il generare la vita dall’altra - anche l’uomo si ammala e prova dolore e anche la donna lavora.
Qui si apre per l’uomo una nuova storia che è ormai segnata inevitabilmente dal peccato e che però Dio riesce a modificare. Nemmeno Lui può cancellare il fatto che il peccato ci sia stato. Neppure Dio può, davanti alla donna che ha preso il frutto e che l’ha mangiato insieme all’uomo, intervenire e dire: “No, facciamo così, fermiamo tutto, torniamo indietro di tre giorni e ricominciamo daccapo”. Se la donna ha mangiato il frutto, l’ha mangiato e non ci sono santi. Ma Dio può cancellare il peccato intervenendo nella realtà di peccato e modificandola e quindi trasformando le conseguenze del peccato in possibilità di salvezza e entrando ora in questa storia dell’uomo che ormai è diversa da prima. Ormai non può più essere come era prima di mangiare il frutto. E però Dio può accompagnare, continuare ad essere vicino all’uomo in questa sua realtà, in questa sua nuova storia segnata dal peccato, ma da un peccato che è perdonato, che l’uomo allora può lasciarsi perdonare.
Ed è quello che avviene quando Dio parla di morte. E guardate che la morte qui assume questa connotazione positiva di offerta di salvezza, ma presentata come la realtà negativa, maledetta, che vuol dire tornare alla terra. Solo che la terra non è più quella di prima, adesso la terra è stata maledetta dal peccato dell’uomo. Quindi è un tornare alla terra che non è più il tornare alla terra che ti riconosce, la terra madre. Torni ad una terra che a motivo di te è stata maledetta. Eppure anche questo ritorno alla terra può avere questa dimensione salvifica perché Dio è capace di perdonare.
L’uomo e la donna vengono cacciati dal giardino e dunque entrano in una nuova storia e in nuovo rapporto con il mondo, che non è più quello di prima perché adesso la terra su cui l’uomo e la donna vivono e la terra a cui ritornano morendo, non è più quella benedetta del giardino, ma quella maledetta che produce solo spine e cardi. Quindi la storia dell’uomo ormai è cambiata, segnata inevitabilmente dal male che l’uomo ha commesso. Ma dentro questa storia pur così segnata dal male, dal peccato, dalla sofferenza, Dio non lascia solo l’uomo. Allora la donna si chiama Eva (Hawwah), che è un nome che ha a che fare con il verbo hayah che vuol dire vivere e far vivere, e infatti si dice: “La chiamò Eva perché fu madre di tutti i viventi”.
Dunque nonostante la conseguenza del peccato sia la morte, la vita continua, perché la fedeltà di Dio continua, perché l’amore di Dio continua, perché Dio perdona. Quando se ne vanno dal giardino, loro che erano nudi vengono rivestiti da Dio con dei vestiti di pelle. Che se da una parte dicono che quest’uomo e questa donna hanno peccato, perché se non avessero peccato non ci sarebbe bisogno dei vestiti, dall’altra segnalano che però questo peccato, Dio lo può e lo vuole recuperare, che Dio non abbandona l’uomo in balia del peccato, ma che Dio entra dentro la situazione di peccato dell’uomo per trasformarla in luogo di perdono, di amore e di grazia.
Allora quei vestiti di pelle stanno lì a dire che dove è abbondato il peccato - e si vede perché ci sono i vestiti - è però sovrabbondata la Grazia, e si vede, perché quei vestiti sono il segno dell’amore di Dio. Così termina il nostro racconto con però l’angelo, i cherubini, con la spada fiammeggiante che adesso impediscono la via all’albero della vita. Questo è evidente perché l’albero della vita era l’albero a cui l’uomo poteva accedere se non mangiava dell’albero della conoscenza del bene e del male. Adesso non può più accedere alla vita, perché prendere dell’albero della vita da parte dell’uomo sarebbe una pretesa di vita eterna. Perché ha preso dell’albero della conoscenza del bene e del male per essere come Dio, e se allora adesso credendosi Dio, volendo essere Dio, prende la vita, quella è la vita eterna e l’uomo non può, quella è di Dio.
Allora ecco l’affermazione insieme dolorosa ed ironica di Dio che dice: “Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi”. Ironicamente ma anche dolorosamente, nel senso che questa è stata la pretesa, ed ecco allora però non stenda più la mano e non prenda dell’albero della vita e viva per sempre. E non perché Dio non vuole che l’uomo viva, ma perché sarebbe quello strappare una vita che non appartiene all’uomo perché ormai l’uomo che pretende di essere Dio non può più accedere ad una vita che non può più essere per lui vita eterna nella misura in cui è vita strappata, ma può essere vita eterna solo nella misura in cui l’uomo, accettando l’ultima offerta di salvezza che è la morte, riconosce di aver bisogno di perdono. Allora sì, lasciandosi perdonare, può attraversare la morte e uscirne vivo per sempre perché salvato. dalla risposta della donna. La donna non risponde: “No, di tutti gli alberi del giardino noi possiamo mangiare!”, perché è questo quello che aveva detto Dio (kol, di ogni albero o di tutti gli alberi).
Genesi 4
Parliamo dell’episodio di Caino e Abele. Ricordiamoci sempre che stiamo leggendo dei testi che sono dei testi fondatori, testi delle origini, dove non si vuole raccontare la storia nel suo svolgersi temporale e cronologico, ma come abbiamo detto tante volte, si vogliono dare delle indicazioni di senso. In Gen 3 il testo ci ha detto che, nonostante il sogno di Dio, nonostante il fatto che il Dio creatore buono abbia fatto buona ogni cosa, l’uomo può rifiutare il dono e quindi usare della propria libertà per delle scelte che rifiutano il progetto di Dio ed il bene e questo si vede in modo evidente nella scelta della donna e dell’uomo nel giardino e poi si vede in modo altrettanto evidente nell’episodio di Caino e Abele. E’ un racconto che ci dice in che modo l’uomo può drammaticamente sottrarsi al progetto di Dio e rifiutarlo.
Il cap. 4 comincia facendo riferimento al fatto che l’uomo conosce Eva, la sua donna, ed essa “concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore” - oppure si potrebbe tradurre: “Ho generato un uomo con il Signore”. Non si capisce bene qui il senso preciso di questa frase di Eva, perché il narratore utilizza un termine, il verbo qanah, che qui funziona perché deve giocare in assonanza con il nome Caino. Caino in ebraico si dice Qajn e si usa il verbo qanah. E’ chiaro che il verbo usato deve giocare con il nome Caino, ed è però un verbo che ha una pluralità di sensi. Perché vuol dire acquistare, ma può anche voler dire generare, addirittura creare.
Qui vuol dire: ho generato, ho creato un figlio con il Signore. Il termine usato non è figlio, ma uomo. Eppure dal Signore. Non è chiara la sequenza precisa delle parole, ma il senso è chiaro: è l’esplosione di gioia della donna che riconosce nel Signore il donatore di questo figlio. E ne dà testimonianza e perciò dà a questo figlio un nome che ricordi questa sua esperienza.
Quello che è interessante è che questo Caino è il primo frutto del primo conoscersi dell’uomo e della donna. Uomo e donna che sono stati cacciati dal giardino, uomo e donna che con il loro peccato hanno ferito a morte la vita, e quindi hanno radicalmente alterato il rapporto di armonia con la vita e che però continuano ad essere oggetto dell’amore fedele di Dio, che non solo dà loro vestiti di pelli, ma tiene fede alla sua promessa di vita. Quindi nonostante l’uomo e la donna abbiano ferito a morte la vita, Dio fa sì che la vita, nonostante tutto, continui. Quest’uomo e questa donna si conoscono, la fedeltà di Dio alla vita si manifesta, nasce un figlio. La vita, anche se ferita, continua.
Però è una vita ferita, è una vita che ha in sé il germe del peccato, è segnata dal fatto che l’uomo e la donna hanno peccato. E questo adesso si vedrà. Perché la vita continua, e non una vita qualunque, ma quella di Gen 1, quella a cui Dio è fedele, una vita che si moltiplica, una vita in sovrabbondanza. Non nasce solo Caino, ma nasce anche un altro figlio, proprio a testimoniare che si tratta della vita benedetta, la vita del “Crescete e moltiplicatevi”. Dio rimane fedele alla sua parola di benedizione; allora non nasce solo un figlio, così tanto per dire: “Non blocchiamo proprio tutto”. No, è la vita benedetta! Quindi ne nasce anche un altro, in sovrabbondanza e benedizione.
Nasce Abele, per il cui nome la donna, Eva, non dà nessuna spiegazione, non fa alcun gioco sonoro, ma non ce n’è bisogno, perché Abele in ebraico si dice Hebel, che vuol dire alito, soffio, vapore, quindi cosa inconsistente. Tanto da poter significare vanità ed essere il termine che Qohelet usa in continuazione nel suo Libro, quando dice: “Vanità delle vanità, tutto è vanità”.
Allora ecco nasce Abele, ma con questo nome che già preannuncia la tragedia, perché questo Abele passerà come un soffio inconsistente e subito morirà per l’insensatezza della violenza che ormai si è instaurata nella realtà umana. Infatti avviene che Caino uccide Abele. Quello che è più problematico è però il motivo per cui Caino uccide Abele, perché ad una prima lettura del testo Caino uccide Abele per gelosia, per invidia, perché non sopporta che Abele gli sia preferito da Dio. Bisogna cercare di capire di che si tratta.
Il testo presenta questi due fratelli e nella misura in cui sono due, inevitabilmente il testo sottolinea il fatto che sono diversi. D’altra parte, l’abbiamo detto, se sono uguali non sono due, ma uno solo -ricordate il discorso sulla separazione. Questi sono due e quindi sono inevitabilmente diversi. Una prima diversità assolutamente fondamentale ed evidente è che uno è primogenito e l’altro secondogenito, e questo fa una grande differenza. Perché nel mondo biblico il primogenito era quello che riceveva l’eredità, la benedizione. Vi ricordate nella storia di Giacobbe e di Esaù, la faccenda delle primogenitura e poi della benedizione che Giacobbe carpisce con l’inganno ad Isacco, e che una volta che la benedizione è data è data e per l’altro rimane solo una benedizione di altro tipo, di “seconda classe”.
Qui non c’è scambio di persona come nella storia di Giacobbe e di Isacco, c’è solo il fatto che uno nasce per primo e l’altro per secondo e questo cambia radicalmente le cose. E d’altra parte questa è una diversità assolutamente ineliminabile dalla natura stessa del nascere come figlio. Non è che ci sia un’ingiustizia nel fatto che uno è primogenito, l’altro secondogenito. Se nasce più di un figlio inevitabilmente uno nasce prima e l’altro nasce dopo. Vale anche per i gemelli che sono nella pancia della stessa madre e nascono nello stesso parto: uno esce prima, l’altro dopo. Oggi noi sappiamo che il primogenito è quello che nasce dopo, ma allora si basavano su quello che vedevano, quindi il primogenito era il primo che nasceva. Allora uno è il primogenito, l’altro secondogenito. L’uno è portatore di privilegi, l’altro no.
Poi c’è una diversità presentata dal testo che è una diversità di lavoro e di cultura. Perché Caino è agricoltore, Abele è pastore di greggi. E’ probabile che dietro a questo racconto ci siano problemi sociologici di continua rivalità che c’erano tra gli agricoltori che erano sedentari e stabilizzati e i pastori nomadi. Può darsi che ci sia anche un problema di soppiantamento di una civilizzazione da parte dell’altra. Questo può funzionare come retroterra, il racconto è però interessato ad altro, a mostrare come il fratello diventa omicida e perché. Allora, al di là delle possibili implicazioni di tipo sociologico, qui c’è che questi due fratelli sono diversi, come è inevitabile che sia: uno prende una strada, uno ne prende un’altra. Tenete conto inoltre che presentando uno come agricoltore, l’altro come pastore, il testo vuole dire che questi due fratelli in realtà esprimono la totalità dell’umanità, perché voi vi ricordate che, in Gen 2, l’uomo è messo nel giardino perché lo coltivi, ma lì nel giardino dà il nome agli animali. Quindi è insieme contadino e pastore.
Caino e Abele vanno in due direzioni diverse, ma entrambe queste direzioni competono all’uomo, è una diversità normale e inevitabile, connessa con questa diversità del lavoro e della cultura, perché è chiaro che se uno è sedentario ha tutta una cultura e un modo di vedere le cose diverso da quello che invece è nomade. Legato alla cultura, al modo di capire il mondo e al tipo di attività che si svolge è anche la forma del culto. Perché è chiaro che un nomade avrà un’espressione cultuale, nei confronti di Dio, diversa dal contadino che è sedentarizzato. E quando poi si tratta di fare delle offerte, uno porta le offerte dei campi, l’altro quelle dei greggi. Questi due offrono cose diverse, ma perché, inevitabilmente, occupandosi di cose diverse, vivendo in ambiti diversi, usano per il culto le cose che sono proprie della propria situazione.
Notate che il testo non indica alcuna differenza in queste offerte che possa spiegare il diverso atteggiamento da parte di Dio. Il testo dice: “Caino portò in offerta i frutti del suolo e anche Abele portò i frutti del suo gregge (i primogeniti del suo gregge)”. Si dice in Gen 4,3: “Caino porta offerta al Signore e Abele porta anche lui i primogeniti del gregge”. Dunque c’è un portare quello che i due possiedono. E basta. Non si dà un giudizio sul fatto che uno porta una cosa buona, l’altro una cosa cattiva o sul modo di portare, di offrire queste cose negativo o positivo.
Eppure questi due fratelli hanno una percezione diversa, sia del loro rapporto con Dio, sia di ciò che tutto questo comporta, il modo di percepire la vita. Se volete un diverso modo di riuscire nella vita, che viene espresso nel testo attraverso l’esplicitazione di un diverso accoglimento da parte di Dio: “E guardò il Signore verso Abele e verso la sua offerta e verso Caino e verso la sua offerta non guardò”. Allora che uno si senta guardato o non guardato vuol dire che uno percepisce diversamente il rapporto con Dio in termini anche di fortuna, di benessere, di riuscita nella vita.
Dunque questi sono diversi perché uno è nato prima e l’altro è nato dopo, sono diversi perché fanno lavori diversi quindi hanno culture diverse e forme di culto diverse e infine hanno una percezione diversa del loro rapporto con Dio e del loro rapporto con la vita e con la riuscita nella vita. Questa percezione del rapporto diverso è espressa dal testo con questo modo di dire: “Guardò, non guardò”. Innanzitutto guardate proprio l’ordine delle parole che è importante: “E guardò il Signore verso Abele e verso la sua offerta e verso Caino e verso la sua offerta non guardò”. Questo tecnicamente si chiama un chiasmo, una forma stilistica particolare, in cui c’è un elemento A, poi un elemento B, poi di nuovo un elemento B e poi un elemento A. Sono uguali e simmetrici ma messi al contrario.
A - E guardò il Signore
B - verso Abele e la sua offerta
B - verso Caino e la sua offerta
A - non guardò
I due elementi centrali sono assolutamente identici, questo vuol dire che nel testo non c’è assolutamente nessun cenno al fatto che l’offerta dell’uno fosse buona e l’offerta dell’altro cattiva. Il testo dice che tutta la differenza sta in quel “guardò... non guardò”. Tutta la differenza sembrerebbe stare in Dio. E di questa differenza il testo non dà spiegazioni. Si tenta allora disperatamente e pateticamente di trovare delle spiegazioni che giustifichino il comportamento di Dio. Allora si tende a dire che Caino quando offriva i frutti del suolo, a differenza di Abele che offriva i primogeniti del gregge, prendeva invece i frutti striminziti, possibilmente marci, perché era avaro.
I frutti – altri argomentano – sono molto graditi a Dio, perché Dio non vuole che la vita venga uccisa, tanto è vero che in Gen 1 dà sia all’uomo che agli animali in cibo l’erba addirittura, ma siccome saremmo nel momento del passaggio dall’agricoltura alla pastorizia si dice che invece anche i sacrifici animali sono graditi a Dio per cui si sostiene che Dio gradisce il sacrificio di Abele. Però non c’è traccia di questo nel testo, e noi dunque rimaniamo alle prese con un’affermazione misteriosa che, a prima vista, ci fa venire la voglia di pensare che dunque Dio qui si comporta in modo ingiusto.
Questo perché noi abbiamo come retroterra, nel leggere questo testo, una categoria soggiacente, che è quella della giustizia retributiva. Per cui se uno fa il bene gli si dà in premio il bene, a chi fa il male si dà il male. Ma questa è la giustizia retributiva che innanzitutto non è la giustizia di Dio, e che comunque non è la giustizia di cui l’uomo fa esperienza perché l’esperienza dell’uomo è che invece questo automatismo - per il quale se tu fai il bene tutto ti va bene e se fai il male tutto ti va male - è continuamente smentito. C’è persino un intero libro della Bibbia di ben 42 capitoli, il Libro di Giobbe, che serve a dire che questo non è vero.
Non si può rimanere in questa visione, bisogna abbandonare questa idea retributiva e dunque non può essere quella la categoria per giudicare e tanto meno per capire il comportamento di Dio di cui si parla in Gen 4. Bisogna andare oltre e altrove. Questo oltre e altrove, sembra chiaramente dire il testo, è il mistero della elezione divina. E’ il mistero della libera scelta da parte di Dio, di chi vuole e come vuole. Facendo però attenzione a capire che quando noi diciamo che Dio sceglie uno, questo non vuol dire che rifiuta l’altro. Anche se il testo lo esprime così: guardò l’offerta di Abele, non guardò l’offerta di Caino. Questo però va capito nel modo di esprimersi biblico dove questo guardò e non guardò non va preso alla lettera e non va capito come sceglie e rifiuta. Vuol dire solo: prediligere uno, ma senza che questo faccia torto all’altro. Vuol dire semplicemente prediligere uno nel senso che su uno Dio ha un progetto particolare che non vuol dire che quindi sugli altri non ha progetti e li butta via, ma semplicemente che su uno ha un progetto particolare che peraltro deve poi servire a tutti gli altri.
Questo è il mistero dell’elezione di Israele, questo è il mistero della libera decisione di Dio di entrare in un cammino di incarnazione. Per cui se vuole che la sua Parola si incarni in parole umane deve necessariamente scegliere una lingua, deve scegliere un popolo che scriva queste cose e che le scriva con quella lingua, con quei riferimenti culturali, in un determinato periodo della storia perché non esiste l’uomo che scrive così, slegato dalla storia. Perché scriva bisogna che sia nato, e nato in una certa epoca e non può essere nato in tutte le epoche e in tutti i luoghi del mondo e utilizzando tutte le lingue del mondo. Quando poi addirittura questo cammino di incarnazione si fa definitivo ed è il Figlio di Dio, il Logos eterno, che si fa uomo, qui entriamo ancora più radicalmente in questa scelta, perché se si fa uomo, non vuol dire che si fa persona umana in genere.
Si fa uomo, il che vuol dire che si fa ebreo, maschio, nato in quel posto, in quel periodo e non in un altro, parlando quella lingua, pensando come pensavano quelli, pregando come pregavano gli ebrei di quel tempo, con dei riferimenti storici che sono quelli e non altri, con il problema dei romani dentro casa. E quello è Dio, è il Salvatore di tutti. A noi piace pensare che siccome è il Salvatore di tutti, allora lo pensiamo slegato da ogni coordinata concreta e storica e così noi europei ce lo immaginiamo con i boccoli biondi, perché a noi piace biondo ed è più bello, con gli occhi azzurri, una sorta di Brad Pitt, Paul Newman. Soprattutto noi lo pretenderemmo fortemente occidentale e possibilmente italiano. Per esempio che parli la nostra lingua, invece di diventare pazzi a studiare l’ebraico e a fare tutto lo sforzo di capire un mondo concettuale diverso dal nostro.
In altre parole noi vorremmo evitare il discorso dell’incarnazione perché quello ci costringe ad una conversione spirituale e mentale che è molto scomoda. Noi preferiamo allora inglobarlo dentro i nostri schemi. Per cui se uno dice che il Signore Gesù è il Messia di Israele, noi rispondiamo: no, è il Salvatore nostro! E’ vero, ma è il Salvatore nostro perché è il Messia di Israele. Ci piaccia o no. E d’altra parte, per incarnarsi bisogna che Dio diventasse questo uomo e necessariamente non un altro. Allora che facciamo? Siamo tutti offesi e ci risentiamo tutti e diciamo che Dio è ingiusto perché ha scelto di incarnarsi in Israele invece che in Italia? Questo è il discorso di Caino e Abele, il discorso dell’elezione, il “guardò” e “non guardò”. A noi non ci ha guardato? Sì, solo che il progetto particolare di salvezza di Dio è di Israele, poi è per tutti, a noi ci guarda eccome, ma se noi lo mettiamo nei termini dell’elezione, dobbiamo dire che ha sceltonon ha scelto noi - se vogliamo utilizzare questa espressione, che però non corrisponde al nostro modo di esprimerci, perché quando noi diciamo: non ha scelto noi, immediatamente traduciamo: ci ha rifiutati.
Non è questo il modo di parlare della Bibbia. La traduzione italiana è fuorviante, perché vi si dice che Dio: “Gradì” le offerte di Abele. In realtà il verbo ebraico significa “guardare”, un guardare compiacendosi in quello che si guarda - non è propriamente gradire. C’è una differenza che è una differenza minima nella misura in cui questo guardare non è il vedere, ma guardare accogliendo.
Ma il fatto che voi facciate tante domande sul significato esatto del termine, mi fa pensare che voi state disperatamente tentando di giustificare Dio e di dire che Dio è ingiusto se fa così. Perché ditemi voi che differenza fa se io dico: “gradì l’offerta”, o “guardò l’offerta”? In ogni caso stiamo dicendo che Dio ha guardato un’offerta e l’ha gradita. Che guardi o che gradisca il fatto è che una la guarda e la gradisce, l’altra non la guarda e non la gradisce. Non cercate di scappare davanti a questo problema. Allora bisogna invece capire cosa dicono questi quando dicono un verbo positivo e poi con un “non” davanti, al negativo.
Ci sono due testi importanti per capire questo. Uno è il salmo78, 67-68: Israele e
| Traduzione italiana | Versione ebraica |
| Ripudiò le tende di Giuseppe, | Rifiutò le tende di Giuseppe |
| non scelse la tribù di Efraim; | e la tribù di Efraim non scelse |
| ma elesse la tribù di Giuda, | e scelse la tribù di Giuda |
| il monte Sion che egli ama. | il monte Sion che egli ama. |
E’ evidente che qui si sta parlando di Israele, e Israele è fatto dalla tribù di Giuda, di Efraim, di Manasse, ecc. Qui però si vuole dire che c’è una scelta particolare nei confronti di Giuda, perché Giuda è il territorio in cui c’è Gerusalemme e in cui c’è il monte Sion, quindi c’è questa scelta perché è sul monte Sion che Dio entra nel Tempio e quindi pone nel Tempio la sua dimora. E’ evidentissimo che in questo testo non si vuole dire che Dio ha rifiutato qualcuno.
Ma la versione ebraica dice proprio che Dio sceglie Giuda e non sceglie Giuseppe, proprio come nel nostro testo guarda un’offerta, non guarda l’altra. Se Dio sceglie Giuda vuol dire che non sceglie Giuseppe, inevitabilmente, perché se sceglie di abitare in Sion sceglie Giuda e non sceglie Giuseppe (tribù del nord), ma questo “non scegliere” non è negativo, perché vuol solo dire che se ha scelto uno non poteva andare dall’altra parte. Viene però espresso in parallelo con “e rifiutò”, dove invece è evidente che non ha rifiutato, perché stiamo sempre parlando di Israele, quindi stiamo sempre parlando dell’elezione divina di Israele. Dentro quell’elezione non è che Dio elegge e allo stesso tempo rifiuta, ma per poter dire che ha fatto una scelta, diremmo privilegiata, non perché sia un di più, ma perché da qualche parte doveva scegliere di mettere il tempio e ha scelto Sion, si dice “non scelse”. Dire che ha scelto Sion vuol dire che non ha scelto gli altri e si può esprimere questo “non aver scelto” gli altri usando il verbo “rifiutò”. Ma quel “rifiutò” non ha il valore che gli diamo noi; è un modo di dire “sceglie – non sceglie”.
L’altro testo importante è in Lc 14,26-27 e in Mt 10,37-38.
Mt 10,37-38:
Chi ama il Padre e la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me”.
Gesù sta dicendo che c’è un amore nei confronti suoi e di Dio, che non può essere lo stesso amore che si ha per il padre e la madre. Perché Dio è assoluto, il padre e la madre no, perché quello è il Figlio di Dio, il padre e la madre no. Quindi Gesù dice: “Chi ama il padre e la madre più di me - quindi rende loro assoluti - non è degno di me” perché bisogna amare i genitori di un amore diverso da quello che si ha per il Signore Gesù. Questo non ci fa problema, ma quando Luca dice la stessa cosa la dice così:
Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo.
Per dire che bisogna amare il padre, la madre, la moglie, i figli, la propria vita, in modo diverso da come si ama lui, e quindi senza amarli di più, senza farne degli assoluti, Luca dice che bisogna odiarli. E’ chiaro che non sta dicendo che bisogna odiare il padre e la madre, sta semplicemente dicendo che bisogna amare Dio e odiare i propri genitori, cioè amare Dio e amare i propri genitori in modo diverso da come si ama Dio e da come si ama il Signore Gesù.
Quando allora in Gen 4 si dice che Dio guarda o gradisce l’offerta di uno e non guarda l’offerta dell’altro, stiamo in questo modo di parlare - è simile all’espressione: ama l’uno e odia l’altro. Vuol dire che inevitabilmente, nel rapporto con le tribù (nel Salmo), e nel rapporto con gli uomini, l’amore di Dio è diverso per ciascuno. Inevitabilmente perché ciascuno di noi è diverso dall’altro e ciò che ci costituisce è l’amore di Dio. E ciò che ci fa diversi è il diverso modo con cui Dio ci ama. Siccome l’unico modo che noi abbiamo per esistere è di essere diversi gli uni dagli altri, questo implica inevitabilmente che Dio ci ama in modo diverso uno dagli altri.
Solo che questo viene percepito da noi, e in questo caso da Caino, come una preferenza ingiusta, perché noi immediatamente tranciamo la diversità in categorie di amare di più e amare di meno. Poiché Caino è il primogenito, il fatto che Abele - che non dovrebbe contare perché è il secondogenito - venga preferito, è percepito da Caino come assolutamente insopportabile. D’altra parte questo è vero per ognuno anche se uno non è primogenito. Che Dio ci ami in modo diverso a me va benissimo, se questo modo diverso con cui Dio ama è favorevole a me. Appena io percepisco la diversità dell’amore di Dio come sfavorevole a me, è chiaro che non mi va più bene e lo considero ingiusto. Senza rendermi conto che io sto trasformando la diversità in più e meno, sto traducendo l’esperienza della diversità invece in un confronto che io opero. E invece di stare a guardare e di essere contento del modo con cui Dio mi ama, mi metto a fare il confronto con il modo con cui a me sembra che Dio ami gli altri, e allora se io faccio il confronto inevitabilmente uso le categorie di più e meno. E appena il meno è mio e il più è dell’altro, io dico che Dio è ingiusto e che l’altro non ha diritto di esistere, e lo ammazzo.
Il progetto che Dio ha su ognuno di noi non è altro che la nostra identità, perché è la nostra vocazione che corrisponde alla nostra identità. Io sono io nella misura in cui realizzo la vocazione che Dio mi ha donato e il progetto di Dio su di me. Il progetto di Dio su di me non è altro che Bruna. E io sono Bruna solo nella misura in cui accetto di vivere come Bruna. Dio ama me come Bruna ed è questo che mi fa Bruna, e non madre Francesca. Ed è questo che ci fa diverse. Se poi io invece dico: “Ma io e Francesca siamo diverse, solo che Francesca canta bene (l’ho sentita in chiesa) e io sono stonata, allora vuol dire che Dio ama Francesca più di me (non che ha un progetto diverso)”. E’ chiaro che appena io entro in questa prospettiva questo vuol dire:
- Che a me il modo in cui Dio mi ama non mi interessa e non mi piace.
- Che non mi piace il modo in cui Dio ama Francesca. E non mi piace perché o io vorrei essere al suo posto, quindi vorrei che lei non ci fosse per poter essere, io, lei. O non mi piace perché Francesca mi è antipatica, non mi piace il suo modo di pensare e vorrei che lei non ci fosse.
Vedete che in entrambi i casi io vorrei che lei non ci fosse, o perché la vorrei diversa da come è perché così com’è non mi piace, o perché siccome mi piace troppo vorrei essere io al suo posto e per questo lei non può esserci. Comunque sia, io voglio che lei muoia. Vi accorgete che il racconto di Caino e Abele è messo in Gen 4, nei racconti delle origini, non per raccontare la storia dei due fratelli, ma di ogni uomo.
Non possiamo neanche giustificare Caino dandogli come attenuante il desiderio di essere amato. Perché dire che io voglio essere amato, vuol dire che io non credo che Dio mi ama, e che mi sta amando nel modo giusto per me, e che non c’è un altro modo per amarmi di più. Ed è il problema di Caino. Il problema di Caino è la sua non accettazione del modo in cui Dio ama lui e di conseguenza del modo con cui ama Abele. Non è Abele il vero problema di Caino, il problema è lui e il suo rapporto con Dio e il suo modo di capire, di percepire, di accettare l’amore di Dio per lui. Questo è proprio quello che Dio gli dice.
Dio allora interviene per aiutarlo a capire che il problema non è Abele, ma che è dentro Caino e nel fatto che Caino deve riconciliarsi con la propria realtà, con il modo con cui Dio lo ama e quindi essere contento dell’amore che Dio ha per lui. Ecco che Dio interviene precisando il vero problema:
“Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo”
Questa frase di Dio in ebraico è molto complessa ed è difficile da capire, ma il senso fondamentale è questo:
Se tu reagisci bene a ciò che invece ti sta facendo adirare, allora guarda che comunque riceverai grazia e non avrai bisogno di essere triste e abbattuto, se invece reagisci male, allora guarda che il problema è tra te e il peccato, che è pronto ad assalirti in agguato alla tua porta. Ma tu devi essere più forte di lui.
Notate che qui Dio utilizza la stessa espressione “verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo”, che è lo stesso discorso che ha fatto alla donna quando le dice: “Verso tuo marito è il tuo istinto ma lui ti dominerà” e noi dicevamo che significa che tu hai bisogno di tuo marito e lui è più forte e ti domina. Qui Dio sta dicendo che verso di te è l’istinto di questo animale accovacciato alla porta, che sembra così forte, così terribile, ma non è vero. Dio sta rivelando a Caino che il peccato è debole. Tu puoi essere più forte di lui.
C’è la rivelazione della debolezza del male e della possibilità dell’uomo di dominarlo, di essere più forte di lui. Dio sta indicando a Caino il cammino della vittoria sul male, dicendogli che il problema è il modo con cui lui reagisce, con cui si pone davanti a questa percezione dell’amore di Dio. Se reagisci bene non hai nessun motivo di essere triste, se reagisci male allora guarda che il problema è che tu te la devi vedere con il peccato. Ma per quanto terrificante sembri l’animale accovacciato alla porta, tu puoi vincerlo. Notate che in questo discorso che Dio fa a Caino, Abele non viene neppure nominato. Non è che Dio dice: “Guarda, io sì, voglio bene ad Abele, però voglio anche tanto bene a te”. No! Perché non è vero che il problema è Abele, il problema è Caino e il suo rapporto con Dio. E notate un’altra cosa. Caino che percepisce l’amore di Dio per sé come insoddisfacente, perché dice che Dio ama Abele più di lui, è l’unico a cui Dio parla. Dio non parla con Abele, come direbbero a Roma: non se lo fila per niente! Invece corre dietro a Caino perché evidentemente il racconto sta mostrando Dio come il Padre che ama il figlio, lo vede in difficoltà, lo vede in situazione di debolezza e si occupa di lui. Il figlio che non ha bisogno lo lascia andare. E’ il Padre che corre dietro al figlio in difficoltà per aiutarlo ad uscire dalla difficoltà. Tanto è grande l’amore di Dio per Caino.
E siccome questo racconto serve a farci capire che ognuno di noi è Caino, rendiamoci conto di quant’è grande l’amore di Dio per noi, che non parla ad Abele, parla a noi e ci viene dietro, ci rincorre, cerca di convincerci, cerca di recuperarci fino all’ultimo, perfino dicendoci: “Guarda che tu sei più forte del male e io sono con te ed è per questo che tu sei più forte. Io sono qua, parlo con te, non con Abele”.
Ma Caino non accetta e il rifiuto dell’amore di Dio si concretizza nel rifiuto del fratello, come vi spiegavo prima con l’esempio di madre Francesca. Io alla fine voglio che Francesca non ci sia. Questo diventa omicidio. Il versetto ebraico che descrive l’omicidio è stranissimo, letteralmente dice così:
“E disse Caino ad Abele suo fratello ed avvenne mentre erano nel campo, si alzò Caino contro Abele suo fratello e lo uccise”.
E’ strano, si racconta che Caino dice qualcosa ad Abele, ma non si dice cosa - nelle vostre traduzioni voi infatti avete: “e disse Caino a suo fratello: andiamo in campagna”, perché questa è l’aggiunta che mette la traduzione greca della LXX. Allora cosa vuol dire questo? Si può interpretare e disse come parlò. Rimane il problema che non si dice cosa si sono detti e poi quel verbo di solito significa proprio disse. C’è un’omissione nel testo e non mi si può venire a dire che copiando si sono persi un pezzo, perché i manoscritti che noi abbiamo sono del Medio Evo, lavorati dai masoreti, che ti spiegano come leggere le parole. C’è una tale attenzione a questo testo che non è proprio possibile che non si siano accorti che qui si dice “E disse ad Abele” e poi non si riferisce che cosa disse. Ripeto, si inserisce l’aggiunta della LXX, ma è chiaro che si tratta di un modo per facilitare le cose, ma il testo di per sé va preso così: e disse Caino ad Abele. E poi non dice niente, e lo uccide.
La violenza interviene quando le parole sono finite e questa è una costante del testo biblico, che quando parla di nemici dice che rumoreggiano come il mare, o che ruggiscono come leoni, ma non parlano. Perché la parola è portatrice di vita e quando invece si decide la morte non c’è niente da dire.
Caino decide di uccidere il fratello. Così dice il testo: che Caino uccide il fratello. La tradizione giudaica arriva ad una tale profondità di penetrazione del testo da capire ed esplicitare quello che poi il testo dice attraverso il dialogo che si svolge tra Caino e Dio, perché la tradizione giudaica capisce che il male ha una tale forza distruttiva che quando il fratello uccide il fratello si sta uccidendo lui. E’ la forza distruttiva del male. Filone di Alessandria fa questo commento: “Se le parole: Caino si alzò contro suo fratello Abele e lo uccise, suggeriscono a prima vista che è Abele che perisce, esse rivelano invece, ad un esame più approfondito, che è Caino che in realtà si è autodistrutto. Bisogna dunque leggere: Caino si alzò e uccise se stesso”.
Questo si vede subito dopo. Perché Dio interviene e fa anche a Caino la domanda come l’aveva fatta all’uomo. Questa volta non è: “Dove sei?”, ma: “Dov’è Abele?” Dio che si mette dalla parte della vittima, che in Gen 3 aveva cercato l’uomo e qui cerca la vittima innocente. E’ una domanda che non si aspetta risposta circa la fine di Abele, Dio sa benissimo ciò che è successo, ma deve servire a Caino. Come quel: “Che hai fatto?” Il “Che hai fatto?” rivolto all’uomo e rivolto ora a Caino per metterlo davanti alle sue responsabilità. E’ una domanda che accusa, ma che serve a fare verità per poter salvare l’uomo peccatore. Perché finché l’uomo non prende coscienza di essere peccatore e di dover essere salvato, non si lascia salvare.
Allora ecco le domande accusatorie di Dio che servono ad aiutare Caino a capire di avere bisogno di essere salvato. Caino si rifiuta al dialogo liberante e salvifico e si rifiuta di confessare. Solo che questo rifiuto: “Non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello?” diventa anche però drammaticamente il rifiuto di se stesso e della propria identità. Sono forse io il guardiano di mio fratello? Perché mio fratello non c’è più e Caino sta dicendo che lui ormai non è più il fratello di nessuno. Rifiuta il suo ruolo di fratello maggiore - qui dice il guardiano, ma sarebbe il custode del fratello minore - ma così manifesta la realtà. Rifiutando di essere il fratello di Abele, Caino non è più il fratello di nessuno. Caino quindi non è più nessuno, perché la sua identità era essere fratello di Abele. E ora si comprende: “Che cosa hai fatto?” La domanda accusatoria e la rivelazione di quello che è avvenuto.
“Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra”.
Ecco la risposta di Caino:
Disse Caino al Signore: “Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere”.
Come prima per l’uomo e la donna, sottoposti alla domanda di Dio che vuole fare verità, Caino si ritrova a dire non la verità su ciò che ha fatto, ma la verità di ciò che adesso è avvenuto a motivo di quello che lui ha fatto. Non è Dio che lo manda in giro ramingo, è lui che ormai non può che essere ramingo, perché la terra ormai è imbevuta del sangue di suo fratello ed è lui che ormai è in balia di chiunque lo incontri perché è lui che ha deciso di non voler essere fratello di nessuno.
Allora adesso il contadino stabile e sedentarizzato diventa nomade, proprio come Abele, solo che ora diventa nomade nella maledizione e chiunque lo incontrerà lo potrà uccidere. Alterati tutti i rapporti. Quello con la terra che è sterile e non dà più vita perché si è imbevuta del sangue del morto. Alterati i rapporti con i fratelli perché tutti lo vogliono uccidere. Alterati i rapporti con Dio perché lui deve fuggire lontano da Dio.
A questo punto Dio risponde in modo analogo a quando aveva dato i vestiti di pelle ad Adamo ed Eva, mettendo un segno su Caino così che non venga ucciso. Il segno però deve indicare che chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte. Allora guardate che questo segno è sì un segno che protegge la vita di Caino, ma è un segno che condanna Caino ad una vita che può persino essere peggio della morte. Perché Caino adesso rimane in vita e nessuno lo uccide, non perché lo amano, non perché rispettano la sua vita, ma solo perché hanno paura della vendetta.
Caino adesso è vivo solo perché gli altri hanno paura e pensano a se stessi, non perché lo amano. Caino è vivo solo perché gli altri pensano così di mettersi in salvo. La solitudine di Caino ormai è radicale e per poter uscire da quella solitudine, da quell’autodistruzione per cui Caino si è alzato e ha ucciso se stesso, per poter uscire anche da quel segno bisogna aspettare un altro segno. E questa volta sarà il segno definitivo, quello sì che davvero salva, il segno della croce, in cui si manifesta un diverso modo di essere fratello e in cui il fratello primogenito, il Signore Gesù, non uccide i fratelli, ma anzi dà la vita per loro, per amore loro e perché questi fratelli siano definitivamente salvi e salvi persino da quel segno di Caino che viene così definitivamente sostituito dal segno della croce.
Ma il Signore gli disse: “Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!” . Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden.
Concilio Vaticano II
Constituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo « Gaudium et Spes », § 48
L'uomo e la donna, che per l'alleanza coniugale « non sono più due, ma una sola carne », prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, esperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità.
Cristo Signore ha effuso l'abbondanza delle sue benedizioni su questo amore dai molteplici aspetti, sgorgato dalla fonte della divina carità e strutturato sul modello della sua unione con la Chiesa (Ef 5,32). Infatti, come un tempo Dio ha preso l'iniziativa di un'alleanza di amore e fedeltà con il suo popolo cosi ora il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane con loro perché, come egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per essa (Ef 5,25) così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione.
L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dalla azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi in maniera efficace siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nello svolgimento della sublime missione di padre e madre. Per questo motivo i coniugi cristiani sono fortificati e quasi consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato. Ed essi, compiendo con la forza di tale sacramento il loro dovere coniugale e familiare, penetrati dello spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione, ed assieme rendono gloria a Dio.

Nessun commento:
Posta un commento